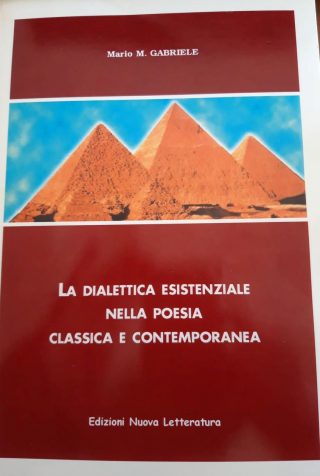PREMESSA
Un’antologia che ponga al centro della ricerca la dialettica esistenziale, non può, per ovvie ragioni di sintesi operativa, spaziare su tutti i documenti poetici sul tema della morte, essendo così ampio l’arco di tempo in cui viene svolta la campionatura, già per se stessa difficile e monotematica, da giustificare ampiamente alcune scelte e rifiuti nell’ambito di un repertorio letterario attestante i vari flussi di coscienza espressi tra fede e ragione.
La ricerca si è indirizzata su tutto ciò che è memoria e storia del poeta, attraverso testi correlati a una situazione privata o collettiva, come autentico —engagement- con il lettore di fronte alle diverse chiavi di lettura del mondo metafisico e di quello empirico.
Si sono, infatti, estrapolati dal vasto casellario poetico, nomi particolarmente significativi, senza alcuna preclusione di stile e di tendenze letterarie, per una proiezione dei sentimenti, che raramente sconfinano nel canto funebre o nella disperazione.
Si tratta per lo più di autentici smarrimenti esistenziali che, tra quesiti e risposte inquietanti, lasciano lo spazio aperto al problema dell’essere e del non essere fino alla estrema ricerca di Dio.
La domanda sempre più crescente del perché della vita e della morte che fece dire a Pascal: “Come non so donde vengo, così non so dove vado; e soltanto so che, uscendo da questo mondo, io cado per sempre o nel nulla o nelle mani di un Dio irritato, senza sapere quale di queste due condizioni mi deve toccare eternamente in sorte”(1), trova da sempre nell’universo scientifico e nella filosofia delle religioni le uniche vie dalle quali ottenere risposte al grande problema della verità.
La lettura dei testi consente, tuttavia, l’avvicinamento ad una visione della poesia come – oggetto reale – della sintesi tra finito e infinito, tra assoluto ed effimero, in una pluralità di connessioni psicosoggettive, che disegnano una mappa di allarmante solitudine per un approdo ai siti dell’anima, tra variazioni di scrittura e alterne emozioni interattive.
(m.m.g.)
____________________
(1) Blaise Pascal, Pensieri, Biblioteca Universale Rizzoli . Traduzione di Vittorio Enzo Alfieri, dicembre 1952,
TRA RELIGIONE E MITOLOGIA
La presenza della morte, che fin dalla prima alba sul mondo e, nel corso dei millenni ha subito diverse interpretazioni antropologiche, secondo il progredire delle civiltà e dei popoli, non ha lasciato indifferenti mistici ed eretici.
Intorno a questo problema, largamente recepito come momento di disagio e di forte contrapposizione culturale, si è venuta a formare una civiltà letteraria che ha fatto del tema “esistenziale” una vera e propria religione mitopoietica, all’interno della quale fede e ragione si confrontano nel tentativo di dare un significato alla morte metamorfica o religiosa, che apre spiragli di luce nell’aldilà, e al nulla eterno sempre più inquietante, sintesi e approdo del razionalismo puro.
In realtà la morte metamorfica, quella che dà valore alla fine della vita, ha radici lontanissime e si collega alla società primitiva e al tema del “viaggio” che, quantunque oscuro e misterioso, non preclude al defunto il passaggio nell’aldilà.
Questo atteggiamento psicoculturale con l’ultraterreno da parte dei popoli primitivi, ha trovato nella ricerca antropologica riscontri inequivocabili con la scoperta di oggetti e reperti sacrificali, catalogati come elementi di culto nei confronti della natura e delle divinità polimorfe.
“Senza dubbio gli uomini del Paleolitico superiore credevano in un al di là. Numerose tombe ci danno notizia dell’inumazione dei morti, che venivano sepolti in fosse semplici o rivestite di lastre di pietra o di omoplate di mammut. I morti portavano i loro abiti e i loro ornamenti e spesso erano spalmati di ocra rossa, per il viaggio verso gli eterni campi di caccia con una fitta oggettistica fatta di armi e di cibarie”.(1)
Non diverso dai riti della società primitiva, era il sentimento religioso dei popoli dell’area mesopotamica e mediterranea che oltre alla pratica del sacrificio di giovani vittime, credevano in una gerarchia divina con poteri di bene e di male su tutti gli esseri viventi.
Nella mitologia ellenica la morte era il luogo delle ombre dove trovavano dimora oracolisti e anime evanescenti. Ulisse e Orfeo sono stati i primi “viaggiatori” che hanno gettano un ponte tra i vivi e i morti, per interrogare e interrogarsi sul proprio destino.
La civiltà egizia, più evoluta sul piano delle conoscenze scientifiche e dell’organizzazione statutaria tra nobili e sudditi, riconosceva in Osiri il dio dell’aldilà, pur avendo sistemi teologici diversi .
Soltanto il faraone, dopo il trapasso, assumeva ruoli divini in quanto re-dio, mentre dignitari e funzionari non avevano accesso ai livelli superiori.
Il discorso intorno alle divinità si amplia ulteriormente con le altre religioni storicamente più consolidate, quali il buddismo, l’islamismo e il cristianesimo, ognuna con propri dogmi e verità.
……………………………………
(1) Alfred Rust “L’uomo primitivo”- traduzione di Maria Attardo Magrini da “ I Propilei”- Grande Storia Universale- Mondadori settembre 1980, pag. 249.
Credere che la vita continui dopo la morte è il desiderio di ogni credente di fronte alla prospettiva del limite temporale.
Non a caso alcune religioni orientali superano l’mpasse della fine della vita con alcuni “passaggi” dell’anima che si colloca in altre forme e ambienti.
“Secondo la religione induista, una delle grandi religioni istituzionalizzate che ha fatto della reincarnazione un punto fondamentale del proprio credo, questo ciclo di morte e rinascita, che viene chiamato —Samsara-, ha lo scopo di avvicinare progressivamente l’anima a Dio, in quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, un processo evolutivo dello spirito. La dottrina della reincarnazione non fa parte solo della religione induista. Nell’antica Grecia, infatti, tale credenza era abbastanza diffusa. Ne parlava Pitagora e perfino Platone che, nel suo “Fedro”, descrive qualcosa di molto simile al —Samsara- induista.” (2).(Marco Fornari, “Alla ricerca delle vite passate” da:” The X Files,” Rivista del fantastico e del mistero, anno II, marzo 1996,n. 6, pag.38).
Nella Roma imperiale il rito magico-religioso confluiva nella cerimonia delle Suovetaurilia in cui erano solo gli animali ad essere sacrificati alle divinità e non gli esseri umani come nel mondo egizio dove erano i servi a seguire nella morte i loro dignitari o padroni.
L’aornos cioè il -luogo dove non volano gli uccelli- ma anche città di Dide o Averno, suscitava nei Romani il terrore o metus dell’al di là, che non sempre richiamava alla mente, come in Lucrezio, la visione di un mondo minaccioso
Al rito funebre i Romani dedicavano le parentalia, un periodo di 10 giorni nei quali si susseguivano le laudatio o orazioni per il defunto, che veniva preparato alla vestizione con la migliore toga pretexta e col naulum o soldo per Caronte, prima di giungere al luogo della cremazione chiamato ustrina.
“Generati dalle credenze religiose che in ogni stadio di civiltà l’uomo ha elaborato in connessione al mistero dell’al di là, i riti funebri si differenziano, sostanzialmente su tre indirizzi di principio: (a) credenza nella totale estinzione del corpo; a essa si collega principalmente l’uso della cremazione, di cui sono conferma i vari vasi cinerari di terracotta del tardo Neolitico sia in Europa, ove l’uso è alternato con quello della inumazione, fino all’avvento del cristianesimo, sia in Asia minore (Mesopotamia), sia tra gli Aztechi del Messico; mentre gli Indù usano ancora oggi la cremazione e la dispersione al vento delle ceneri. (b) credenza in un sonno con risveglio o, come il cristianesimo, nella resurrezione della carne, essa si manifesta con l’uso dell’inumazione che, nelle forme di civiltà primitive,vedeva il cadavere contratto, su di un fianco, mentre è disteso e prono negli stadi di più alta civiltà. (c) credenza che, dopo la morte, il corpo viva un’altra vita sensibile: a essa si collega l’uso di conservare il corpo, mediante mummificazione o essiccazione e di porre, accanto al defunto, viveri vesti, suppellettili e statuette chiamate uscebti per rendergli piacevole la sua lunga vita dell’aldilà. Questi riti erano praticati principalmente in Egitto” (3) (da:Grande Enciclopedia Universale Illustrata delle lettere, delle scienze, della arti, vol.8:”Riti funebri” pagg: 2362-2363,Istituto Enciclopedico Internazionale, dicembre 1975).
L’effimero e l’assoluto e il tempo stesso della vita e della morte caratterizzano la cultura e il sentimento di tutti i popoli nelle diverse ere temporali, Si deve, tuttavia, considerare che di fronte alla realtà terribile della fine della vita una via di sbocco possa venire dalle religioni che, in larga misura e nei limiti dell’umile certezza, concorrono a dare un senso alla impietosa realtà quotidiana, attraverso i dogmi e la “realtà finale” di tutto il genere umano.
Parapsicologia, metapsichica, metempsicosi e misticismo si offrono all’uomo come spazi di fede intorno al fenomeno dell’Inconoscibile.
Il problema della fine dell’esistenza e della morte metamorfica turba e impegna il mondo spirituale di ogni credente.
“Chiuso fra la nascita e la morte, l’uomo sente in sé e nei suoi simili dei limiti che lo inducono a volgere la sua attenzione a qualcosa d’altro in cui egli dovrà passare, limiti visibili-invisibili, di fronte ai quali la sua esistenza vien meno. La radicalità di questa ineliminabile esperienza sa trovare delle risposte ai grandi interrogativi non soltanto in culture tarde e maturate a un alto grado di astrazione, risposte che corrispondono a esplicite domande , quali anche noi esprimiamo: dove si trovano ora i defunti? Sopravvivono essi, e in che modo, e quando torneranno sulla terra? La credenza dell’anima e il culto dell’anima non hanno più dunque soltanto un valore esplicativo, come se esclusivamente la perdita della visibilità corporea rendesse necessaria l’acquisizione di forme invisibili; l’esperienza della vita e l’esperienza della morte formano sin dal principio un’unità, perché nella somazione è compreso il suo momento negativo, l’allontanamento dal soma, o come vorremmo dire con uno straordinario neologismo, la “dissomazione”. Al campo esterno dell’agire appartengono il “momento negativo” e il “vuoto” come sfondo e anello di collegamento con l’immagine della realtà, frantumata in tante entità disperse; venire e sparire, fare e distruggere sono le loro forme di transizione a noi accessibili; e solo il pensiero che riesca a svincolarsi dall’immediato legame con la prassi scopre in essi delle difficoltà concettuali e gli enigmi del divenire e perire, del nulla e dell’essere.”(4) (Helmud Plesner “Conditio Humana”- Traduzione di Maria Attardo Magrini” Dissomazione” da: I Propilei, Grande Storia Universale, Mondadori, Settembre, 1980, pagg.86-87)
Dalla letteratura greca ci perviene una delle testimonianze più alte intorno al tema della morte ed è la tragedia -genere teatrale caratterizzato dallo stile sublime, da personaggi mitici e storici di alto rango, da avvenimenti gravi ed estremi e dallo scioglimento luttuoso. –
-La tragedia greca (le cui origini, molto oscure e discusse, sono tuttavia sicuramente legate al culto di Dioniso), conserva anche in età storica, nei capolavori di Eschilo, Sofocle, Euripide, una funzione etico-religiosa, inscindibile dalla civiltà della polis: la rappresentazione riguarda sempre un mito o un tema storico che intende illuminare la condizione umana, individuale o collettiva, nei suoi aspetti più contraddittori e dolorosi e mostrare come, attraverso la sofferenza, l’orrore e la morte si possa ricomporre un ordine violato, o conquistare un ordine più alto.
Il carattere intrinsecamente etico e problematico della tragedia sopravvive nel corpus di Seneca (caratterizzato dal gusto cupo del sangue) e nella rinata tragedia moderna (cinque-settecentesca), che riprende forme e temi da quella antica per dar voce alla sensibilità e alla cultura dell’aristocrazia europea del tempo. Particolarmente notevole la tragedia classica francese (Corneille e Racine), e quella, tarda, dell’Alfieri -(5) (Riccardo Maltese-Andrea Grillini: Dizionario di Letteratura, arte, cinema e scienze umane; La Nuova Italia, gennaio 1961,pag. 224-225) nonché quella inglese di Shakespeare tutta rivolta a fatti, situazioni e personaggi della storia, e quella spagnola di Lope de Vega, fino a D’Annunzio che apportò numerosi innovamenti.
Ma è davanti a Lazzaro, che Cristo chiude alla morte il senso del Nulla, aprendo all’umanità la porta della Speranza e della Salvezza.
Non a caso la collinetta del Golgota, dove s’innalzano le tre Croci, è il punto più alto che si eleva al cielo, rispetto alla pianura che è la vita. Da questo momento in poi la Storia dell’umanità volta pagina col Dio che si rivela: “sfera il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo ”(6). (Trattasi di una nota di Giose Rimanelli a piè di pagina 48 della Cantica XVIII del volume Alien Cantica An American Journey (1964-1993), con la quale l’Autore ricorda come in un seminario italiano i suoi tutori teologi ripetessero che:”Deus est sphaera cuius centrum ubique”..
……………
Sphaeram claudit curvatura
L’arco include la sfera
Et sub ipsa clauditura.
Ed è incluso in essa.
In hac Verbi copula
In questa copula del Verbo
Stupet omnis regula.
Si confonde ogni regola
Amen
“L’Apocalisse” di San Giovanni, il “Libro” di Enoch, gli “Oracoli Sibillini”, “L’Apocalisse” di Baruch fino al “Testamento” di Isacco sono i siti letterari nei quali il tema della morte domina come castigo divino sul genere umano.
Il cristianesimo, nato col mistero del descensus ad inferos di Cristo, separando luce e tenebra, vita e morte, bene e male, toglie il respiro alle religioni pagane e sovverte il vecchio rapporto uomo-morte collocato in una dimensione non biblica.
Il sentimento religioso trova nella società medievale un ruolo egemone con un’ampia testimonianza poetica che, a partire da San Francesco, mette in rilievo una parte considerevole di letteratura teologica e mistica non disgiunta da un quadro cupo e orrifico della morte, così altamente magnificata ed esorcizzata da San Francesco nel “Cantico di Frate Sole”:
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nulla homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morranno ne la peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male”.
La “morte corporale” appare meno punitiva della “morte secunda” che è lo “stagno di fuoco”. Lo precisa San Giovanni quando dice :“essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere… e se alcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello” stagno di fuoco “ , (Apocalisse 20, 13-15) ed è lo stesso San Giovanni a scrivere :”qui vicerit non laedetur a morte secunda “..(7) (Adolfo Oxilia, Il cantico di Frate Sole, Nardini Editore, Firenze 1984,,pag. 114)
Questa letteratura della salvezza e della dannazione scorre fino a Dante, altro viaggiatore assieme a Virgilio, nel mondo delle ombre.
Non a caso “la Divina Commedia” è un percorso apologetico che, da un basso luogo, aspro, selvaggio e forte (Inferno), passa attraverso atmosfere soffuse di luce aurorale (Purgatorio), per giungere a Dio “L’amor che muove il sole e l’altre stelle” (Paradiso). La rappresentazione delle anime è di tipo allegorico e si collega alla tradizione greco-latina che credeva nell’esistenza delle pene e nella beatitudine dopo la morte.
La punizione, la dannazione eterna, la porta dell’inferno con la terribile epigrafe che preclude ai peccatori la visione di Dio, la “livida palude” dalla quale a nessuno è dato di “riveder le stelle” e lo stesso fuoco riservato ai peccatori, già preannunciato da San Francesco nel suo “Cantico”, si attualizzano nella “Commedia” di Dante con la descrizione sulfurea e tenebrosa del Canto terzo: (vv. 22 ,29 ), dove meglio è descritta la condizione dei dannati:
“Quivi sospiri, pianti e alti guai / risonavan per l’aere sanza stelle, / per ch’io al cominciar ne lagrimai. / Diverse lingue , orribili favelle , / parole di dolore, accenni d’ira, / voci alte e fioche , e suon di man con elle / facevano un tumulto, / il qual s’aggira / sempre in quell’aura sanza tempo tinta, / come la rena quando turbo spira. / e che sempre nel medesimo canto (vv 82,87 ), si fa più dura e senza speranza “Guai a voi, anime prave! /Non isperate mai veder lo cielo; / i’ vegno per menarvi a l’altra riva / ne le tenebre etterne, in caldo e ‘ n gelo.” / mentre “Caron dimonio , con occhi di bragia, / loro accennando, tutte le raccoglie / batte col remo qualunque s’adagia. / Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra fin che ‘l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie/ similmente il mal seme d’Adamo / gittansi di quel lito ad una ad una, / per cenni come augel per suo richiamo. (vv. 109,117) .
LE VIE DELLA RAGIONE
L’’Illuminismoo modula tutta la letteratura apocalittica del duecento e istituzionalizza una nuova civiltà letteraria, dopo un lungo periodo magnificato dalla poesia satirica nelle corti e dall’amore angelicato e le vie della ragione prevalgono sulla ortodossia della Chiesa.
Questo nuovo “pensiero” trova in Rousseau la punta di diamante che incide cuore, sentimento e ragione, mentre Diderot affonda ancora di più la lama dell’ateismo nella coscienza comune e d’Holbach radicalizza la visione materialistica dell’uomo, come soggetto fisico non vincolato dalla morale cristiana.
Con la fine dell’Illuminismo, la letteratura si apre all’estetica neoclassica e la visione della morte trova nei ”Sepolcri” di Ugo Foscolo la strada del “culto dei morti” tramite la Rimembranza dei grandi eroi e delle loro tombe.
E’ la prima indicazione culturale con espliciti riferimenti alla sfera del destino dell’uomo e delle sue opere. Siamo di fronte a una posizione fortemente laica, che va a colpire la morale cattolica, in quanto a prevalere non è la speranza cristiana di una vita ultraterrena, ma l’idea materialista e il bisogno dell’illusione come si rileva da un carteggio del Foscolo:
“Young ed Harvey meditarono sui sepolcri cristiani: i loro libri hanno per iscopo la rassegnazione alla morte ed il conforto d’un’altra vita; ed ai predicatori protestanti bastavano le tombe dei protestanti. Gray scrisse da filosofo; la sua elegia ha per iscopo di persuadere l’oscurità della vita e la tranquillità della morte; quindi gli basta un cimitero campestre. L’autore considera i sepolcri politicamente; ed ha per iscopo di animare l’emulazione politica degli italiani con gli esempi delle nazioni che onorano la memoria e i sepolcri degli uomini grandi, però doveva viaggiare più di Young, d’Harevey e di Gray, e predicare non la resurrezione de’ corpi, ma delle virtù” Ma è con la serie de i ”Sonetti” che Foscolo ci sorprende per via di quella sua sensibilità tutta moderna nel testimoniare la morte come frattura di ogni rapporto privato e sentimentale.
Il ricordo degli affetti familiari e le lacrime sulla tomba non si discostano molto dal nostro attuale atteggiamento emotivo nei confronti dei cari estinti e “In morte del fratello Giovanni” il tema della fragilità dell’uomo e del suo destino sono espressi dal Foscolo con trepidante amore e struggente meditazione.
IN MORTE DEL FRATELLO GIOVANNI
Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo
di gente in gente, me vedrai seduto
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo
il fior de’ tuoi gentili anni caduto.
La madre or sol, suo dì tardo traendo,
parla di me col tuo cenere muto
ma io deluse a voi le palme tendo,
e sol da lunge i miei tetti saluto.
Sento gli avversi Numi, e le secrete
cure che al vivere tuo furon tempesta,
e prego anch’io nel tuo porto quiete.
Questo di tanta speme oggi mi resta!
straniere genti, almen l’ossa rendete
allora al petto della madre mesta.
Tu non altro che il canto avrai del figlio,
o materna mia terra; a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura.
Con “Alla sera” si viene a realizzare un equilibrio sostanzialmente eutimico dell’anima. La similitudine, tra l’altro, efficacissima delle due figure sinergiche sera-morte, offre un inconsueto annuncio di “armonia” evidente nella prima e ultima strofa del sonetto rafforzato da supporti psicologici e simbolici dove il tracciato poetico carica su di sé la meraviglia della natura e la pace dell’eternità
L’idea della morte primeggia sull’ipotesi metafisica o religiosa . La percezione del negativo è totale e assorbe tutta la solitudine dell’uomo di fronte agli aspetti della realtà dichiarati dallo stesso Foscolo:
“Non so cosa sia il mio corpo , i miei sensi, l’anima mia; e questa stessa parte di me che pensa ciò ch’io scrivo, e che medita sopra di tutto e sopra se stessa, non può conoscersi mai. Mi trovo come attaccato a un piccolo angolo di uno spazio incomprensibile, senza sapere perché sono collocato piuttosto qui che altrove; o perché questo breve tempo della mia esistenza sia assegnato piuttosto a questo momento dell’eternità che a tutti quelli che precedevano , e che seguiranno, Io non vedo da tutte le parti altro che infinità le quali mi assorbono come un atomo.”
Su questo viatico di riflessioni il Foscolo lascia al giovane Ortis l’unica alternativa possibile; quella del suicidio come estrema soluzione ad una indagine esistenziale senza via d’uscita. Da qui la rassegnazione alla morte o “fatal quiete” palesemente dichiarata nella serie dei sonetti e che solo nei “Sepolcri” viene considerata in un’altra luce; quella della continuità della vita oltre la morte attraverso il recupero delle grandi imprese che i defunti hanno lasciato ai vivi e che questi ultimi ravvivano nella luce dei ricordi e delle pietre tombali.
ALLA SERA
Forse perché della fatal quiete
tu sei l’immago, a me sì cara vieni,
o sera! E quando ti corteggian liete
le nubi estive e i zeffiri sereni,
e quando dal nevoso aere inquiete
tenebre e lunghe all’universo meni,
sempre scendi invocata, e le secrete
vie del mio cor soavemente tieni.
Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme
che vanno al nulla eterno; e intanto fugge
questo reo tempo, e van con lui le torme
delle cure onde meco egli si strugge;
e mentre io guardo la tua pace, dorme
quello spirito guerrier ch’entro mi rugge.
GIACOMO LEOPARDI
Sulla poetica del Nulla eterno si immette anche Leopardi con “L’Infinito” dove Spazio e Tempo agiscono negativamente su tutta la dinamica dell’esistente.
L’accostamento di alcuni versi 9,10,11,12,13,14 del sonetto “Alla sera” del Foscolo, ai versi 9,10,11,12,13,14,15 de “L’infinito” di Leopardi, pone in evidenza un “naufragio” fisico e spirituale dei due poeti, già annunciato con gli aggettivi “caro” e “cara”: il primo riferibile all”ermo colle” del Leopardi, e il secondo all’immagine della “sera” riconducibile alla “fatal quiete” del Foscolo.
Alcuni elementi come i ”sovrumani silenzi”, gli “interminati spazì” e la “profondissima quiete” , che si muovono nella progressione espansiva e virtuale del pensiero oltre il punto fisico rappresentato dalla “siepe”, presuppongono una organizzazione mentale dell’effimero e dell’eternità, che va al di là della semplice “finzione” creata dal Leopardi che tra sentimento e ragione crea le premesse per una riflessione morale, filosofica, esistenziale e cosmica come punto di attacco a quell’inesplicabile mistero che è la vita.
L’immensamente grande si contrappone all’immensamente piccolo e viceversa ed entrambi interagiscono nelle due sequenze oppositive rappresentate dagli “(in)terminati spazi” e “(sovra)umani silenzi”, tanto che il pensiero opera su due piani altrettanto espansivi e riduttivi del Tempo e dello Spazio che confluiscono poi a breve attimo cosmico, paragonabile al fruscio delle foglie mosse dal vento, dove tutto converge in un medesimo punto: natura e storia, ragione e poesia, finito e infinito in un trionfo del Nulla, già proclamato con: “A me stesso” del ciclo di “Aspasia”, e poi ancora, nel “Pensiero dominante” e in “Amore e morte”.
Tutta la poesia di Leopardi è poesia di riflessione e di contaminazione negativa della realtà. Per questa via lo “Zibaldone” e le “Operette morali” sono il grande tomo della denuncia dell’inganno. Il risultato è quasi sempre consequenziale di una logica che porta ad una amara dichiarazione di nonsense della vita che può essere superata soltanto dall’illusione dell’amore o dal suicidio; quest’ultimo già dichiaratamente considerato negli “Scritti vari inediti”, composti con molta probabilità intorno all’anno 1820, dove tra l’altro vi si legge: ”Il fine della vita è la felicità, ma la felicità oggi appare impossibile. L’uomo antico aveva l’eroismo e le illusioni, aveva le grandi passioni, ed era distratto dal vuoto e dall’angoscia, Ma tutto, col tempo, è impallidito. La cognizione delle cose conduce l’uomo al desiderio di morte, dopo che la filosofia gli ha fatto conoscere che quella dimenticanza di sé che in antico era possibile oggi non lo è più. Continuare in una vita, di cui abbiamo conosciuto l’infelicità e il nulla, è impossibile. Quanto poi al fatto, che molti negano, che le illusioni facessero la felicità dell’uomo antico, resta comunque la differenza fondamentale che allora si viveva anche morendo e oggi si muore vivendo”
Quanto “all’ermo colle” esso funge da “transfert” essendo il luogo più “caro” e amato dal poeta come via di fuga verso mondi sconosciuti e meno ostili della Natura matrigna. “L’infinito” si offre a molteplici interpretazioni critiche, non solo per il linguaggio straordinariamente semplice, quanto per i suoi segreti nascosti.
E qui ritorna attuale l’interpretazione “estatico-mistica” fatta dal De Sanctis, che non trova adesione da parte di Walter Binni il quale ravvisa soltanto elementi sensistici nell’idillio.
Eppure, qualche brivido metafisico si avverte nella lettura del testo. Avvicinarsi col pensiero, ritrarsi sbigottito e perdersi nella ciclicità dei tempi cosmici e negli spazi infiniti, riducendoli a breve voce del vento, è avventurarsi in un mondo che è “altro” rispetto a quello “terreno”.
.La poesia di Leopardi va vista anche alla luce delle indicazioni psicanalitiche.: su questo tema Alfredo Giuliani recensendo il saggio di Giampaolo Sasso dal titolo ” La mente intralinguistica. L’instabilità del segno: anagrammi e parole dentro le parole” pagg. 344 Marietti, su “La Repubblica” del 29 maggio 1994, pagg.24-25, sottolinea che “Nella più celebre delle poesie leopardiane si nascondono alcuni “misteri” che riaffiorano a metà strada “ fra linguistica e psicoanalisi”.
L’INFINITO
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando; e mi sovvien l’eterno
E le morti stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.
Tra surrealismo e romanticismo europeo, si colloca la presenza poetica di Gèrard De Nerval, che, nel sonetto “La grand’mère” incluso nella raccolta ”Chimere e altre poesie” (1924), coglie con estrema efficacia il senso dello smarrimento di fronte alla morte, rimarcando con acuta sensibilità atteggiamenti e situazioni indelebilmente fissati nella memoria.
LA NONNA
Sono passati tre anni da quando la nonna è morta,
– dolce creatura – e quando fu sepolta
Parenti e amici la ricordarono piangendo
Con dolore sincero e amaro.
Io solo m’aggiravo per la casa, sorpreso
Più che triste, e poiché stavo vicino
Alla sua bara, – qualcuno mi rimproverava
Di guardarla senza lacrime e sofferenza.
Dolore chiassoso passato velocemente:
Dopo tre anni altre emozioni,
Le gioie, le pene, – le rivoluzioni -,
Hanno cancellato il suo ricordo nei cuori.
Io soltanto la ricordo, e spesso la piango;
Dopo tre anni, reso duro dal tempo,
Come un nome intagliato nella scorza,
S’incide nel profondo il suo ricordo.
VERLAINE, CORBIERE.
In Francia il simbolismo maudit di Verlaine,Corbière, Rimbaud,Mallarmè- Villon e Baudelaire, pur instaurando un clima poetico di denuncia della limitatezza umana, e dell’insopprimibile desiderio di fuga attraverso il sogno e i desideri dell’anima, non manca di contatti con la poetica del dolore, che viene espressa con aristocratica ironia e superamento del nonsense della vita attraverso le esperienze quotidiane e la trasgressione, a volte, cercando nella religione il punto della propria spiritualità, come in Paul Verlaine che con “Sagesse” (Bruxelles, Librairie Cartholique, 1881), tocca il vertice della letteratura francese, offrendo a Dio il suo oratorio mistico, maturando una nuova forma poetica di intensa musicalità del verso dove non mancano risultati malinconici e di pensosa meditazione:
PAUL VERLAINE
CANZONE D’AUTUNNO
I singulti lunghi
dei violini
dell’autunno
colpiscono il mio cuore
d’un languore
monotono.
Tutto soffocante
e smorto, quando
viene l’ora,
io mi ricordo
dei passati giorni
e piango;
e me ne vado
al tristo vento
che mi porta,
di qua, di là,
come una foglia morta
XXV
O miei morti tristemente famosi
che mi fate un rifugio ombroso
di pace, di preghiera e d’esempio,
come un tempo il Dio vivente
desiderò che un umile fanciullo
si sacrificasse nel tempio:
o miei morti chini sul mio cuore,
pietosi per il suo languore,
padre, madre, anime angeliche,
e tu che fosti più che una sorella,
e tu, giovine pieno di dolcezza
a cui dedico questi versi malinconici
e voi tutti, parte migliore
della mia anima, per la cui dipartita
s’inaridì la mia ora più bella,
amici che la vostra ora recise,
o amici miei, vedete che già
viene il tempo ch’io pure me ne muoia,
Nient’altro che esilio è la terra!
E perché Dio allontana
dalla mia bocca anche il pane,
se non per riunirmi a voi
nel suo seno temibile e dolce,
lontano da questo mondo aspro e feroce?
Preparatemi il cammino
venite a prendermi per mano,
siatemi luce nella gloria:
o meglio — Iddio vendicatore! —
pregate per un povero peccatore
indegno ancora del Purgatorio.
QUANDO ANDREMO
Quando andremo,
nell’ombra del bosco nero,
quando saremo pieni di aria e di luce
in riva al limpido fiume,
quando ci troveremo in un attimo fuori
da questa Parigi di cuori infranti,
e se la bontà lenta della natura
ci cullerà in un sogno senza fine:
allora, prepariamoci a dormire l’ultimo sonno!
Dio penserà al risveglio. (da Epigrammes)
Tristan Corbière, antinarcisista per eccellenza, più malinconico che reazionario alle disavventure umane, cantore della solitudine e della derisione di se stesso, sempre fedele alla propria immagine di maudit, coglie nei momenti di maggiore espansione poetica, attimi di estrema delicatezza nei confronti della caducità della vita, creando spazi di cristallina innocenza e ironia :
RONDELLO
E’ tardi, bimbo, ladro di comete!
Non esistono più notti, non esistono più giorni.
Dormi…. e attendi che arrivino quelle
che dicevano: Mai! che dicevano: Sempre!
Senti i loro passi? Non sono pesanti:
oh, piedi leggeri! — L’Amore ha le ali…
E’ tardi, bimbo, ladro di comete!
Senti le loro voci?.. Le tombe sono mute.
Dormi: ben poco pesa il tuo carico di semprevivi:
i tuoi amici, gli orsi, non verranno
a gettare la pietra sulle tue damigelle:
è tardi, bimbo, ladro di comete!
MORTICINO PER RIDERE
Vattene presto, sognatore di comete.
I tuoi capelli saranno erbe al vento
dal tuo occhio aperto usciranno i fuochi
fatui, prigionieri nelle povere teste….
I fiori di tomba chiamati amourettes
cresceranno sul tuo riso terroso
così pure le miosotidi, questi fiori di carcere.
Non fare il penoso: le bare dei poeti
per i becchini sono semplici giocattoli,
custodie da violino che non hanno suono.
Ti penseranno morto; i borghesi sono sciocchi.
Vattene presto, sognatore di comete.
SHAKESPEARE, MASTERS, ELIOT, JIMENEZ
Temi dichiaratamente esistenziali, che testimoniano l’inequivocabile partecipazione del poeta davanti agli eventi relativi alla sfera privata, come possono essere ad esempio le imprevedibili situazioni all’interno del rapporto vita-morte, in un più ampio discorso anche di tipo metafisico, ci vengono dalla letteratura angloamericana di William Shakespeare, Edgar Lee Masters, T.S. Eliot e di quella andalusiana di Juan Ramòn Jiménez.
Di William Shakespeare si riporta il più celebre dei monologhi: quello di “Essere, o non essere”, che ha visto nel corso degli anni varie traduzioni. Qui lo si propone nella versione della prima edizione in quarto del 1603, per la prima volta tradotta in italiano da Alessandro Serpieri, assieme alla versione definitiva, tratta dal volume in quarto del 1605.
“Da un secolo e mezzo la critica si domanda se le due versioni del dramma siano entrambe di Shakespeare. Il testo più breve, solo ora tradotto in italiano è probabilmente la prima stesura, scritta di getto del grande capolavoro della maturità:
I
Essere, o non essere, sì questo è il punto:
morire, dormire, ed è tutto? Si, tutto.
No, dormire, sognare, sì, certo, qui è il nodo
poiché in quel sogno di morte, quando ci svegliamo
e siamo condotti davanti a un Giudice eterno,
da cui nessun passeggero è mai ritornato,
il paese inesplorato, alla cui vista
i giusti sorridono e i maledetti sono dannati….
Se non fosse per questo, la gioiosa speranza di questo,
chi sopporterebbe gli scorni e le lusinghe del mondo —
chi disprezzato dai ricchi, chi ricco maledetto dai poveri,
la vedova oppressa, l’orfano maltrattato —
e il sapore della fame, o il regno di un tiranno,
e mille altre calamità in aggiunta,
per imprecare e sudare sotto questa faticosa vita,
quando ci si potrebbe dare piena quietanza
con un semplice stilo? Chi sopporterebbe questo,
se non per una speranza di qualcosa dopo la morte,
che sconcerta il cervello, e confonde la mente,
che ci fa sopportare i mali che abbiamo
piuttosto che volare ad altri che non conosciamo?
II
Essere o non essere , questa è la domanda:
se sia più nobile per la mente sopportare
i sassi e le frecce della oltraggiosa fortuna
o prendere le armi contro un mare di affanni
e, contrastandoli, finirli. Morire, dormire….
nient’altro, e con un sonno dire fine
alla stretta del cuore e ai mille tumulti naturali
che eredita la carne: è una consumazione
da desiderare devotamente. Morire, dormire.
Dormire, forse sognare. Ah qui è l’intoppo.
Perché in quel sonno di morte, quali sogni
possano venire , dopo che ci siamo cavati
di dosso questo groviglio mortale,
deve farci esitare. Ecco il motivo
che dà alla sventura così lunga vita.
Perché chi sopporterebbe le frustate e gli insulti
del tempo, il torto degli oppressori,
l’offesa degli arroganti, gli spasimi
dell’amore disprezzato, il ritardo della legge,
l’insolenza delle cariche ufficiali, e gli insulti
che il merito paziente riceve dagli indegni,
quando da solo potrebbe darsi quietanza
con un semplice stilo? Chi vorrebbe portare pesi,
imprecare e sudare sotto una faticosa vita,
se non fosse che il terrore di qualcosa
dopo la morte, il paese inesplorato
dal cui confine nessun viaggiatore ritorna,
sconcerta la volontà e ci fa sopportare
i mali che abbiamo piuttosto che volare
ad altri che non conosciamo?
DALLA SPERANZA AL TERRORE
“L’Amleto curato da Alessandro Serpieri per i Classici Marsilio è un avvenimento culturale perché consente per la prima volta al lettore italiano di affrontare direttamente i problemi testuali del dramma più famoso della letteratura mondiale. C’è un solo Amleto o ce ne sono due? Shakespeare scrisse l’Amleto all’inizio della sua carriera e lo rielaborò più di dieci anni dopo, all’apice della maturità? Non è solo un problema da filologi, perché nel principe Amleto, incunabolo dell’uomo moderno, troviamo qualcosa di ognuno di noi .
Maestro della filologia shakespeariana — dalla grande impresa del “Laboratorio di Shakespeare “ (Pratiche) all’edizione esemplare dei “Sonetti” (Classici Rizzoli) e recentemente al “Macbeth” per i classici Giunti — Serpieri racconta… il suo punto di vista sul “giallo” di Amleto. Unico per lunghezza (dura come due Macbeth), profondità filosofica e popolarità, Amleto lo è anche perché esiste in tre versioni, l’In folio postumo del 1623 e due volumetti autonomi formato in quarto: Q2 (questa è la sigla scientifica in uso) pubblicato nel 1605, che fornisce il testo più completo e autorevole, e Q1, di due anni precedente ma scoperto solo nel 1823, molto più breve e scorretto ma anche profondamente diverso nel testo e nella struttura drammatica. Dal 1823 gli studiosi si dividono in due campi fieramente avversi: Q1 è una versione d’autore, sia pure giovanile e vicina al suo modello (sappiamo con certezza che esisteva un Amleto precedente a Shakespeare, anche se il testo è perduto), o un testo pirata ricostruito a memoria da un attore della compagnia e ceduto a un editore senza scrupoli? E’ una prima stesura o un testo posteriore tagliato e corrotto? Se la prima ipotesi fosse vera, Amleto sarebbe l’unico dramma che permetta di seguire in concreto, attraverso due testi diversi e lontani nel tempo, la maturazione di Shakespeare . Le due tesi restano in equilibrio per tutto l’Ottocento. Poi prevale la tesi dell’edizione “pirata” , che nel secondo dopoguerra finisce per diventare senso comune. Ma recentemente i difensori dell’’autenticità del “primo Amleto” sono venuti alla riscossa. Tra questi si schiera autorevolmente Serpieri, che traduce, annota e pubblica in due volumi separati entrambi i testi , aggiungendovi una rassegna e una discussione critica di tutti gli argomenti pro e contro. Ma la tesi della versione d’autore ha ragioni molto forti. Come potrebbero essere “errori di memoria” i nomi diversi dei personaggi (Polonio si chiamava Corambis), il diverso ruolo drammatico della regina, che in Q1 si schiera nettamente dalla parte del figlio, la diversa età di Amleto che ha vent’anni in Q1 e trenta in Q2 (nel frattempo, infatti, era cambiata l’età dell’attore che lo interpretava il grande Richard Burbage), lo spostamento di scene essenziali, come il monologo: in Q1 la tentazione del suicidio è contrastata dalla speranza, in Q2 dal terrore di ciò che verrà dopo la morte. E’ un errore di memoria, o non è piuttosto la visione dell’autore a essere cambiata, dalle speranze giovanili al pessimismo della maturità?”(8) (Nota introduttiva di Andrea Casalegno a: “Il dilemma dei due Amleti” di Alessandro Serpieri su: “Il Sole 24 Ore” del 18.05.1997.)
IL DILEMMA DEI DUE AMLETI
“Di Shakespeare non ci restano manoscritti. A parte qualche firma su documenti vari, l’unica traccia della sua mano sembra essere stata individuata in una scena di circa centocinquanta righi aggiunta a un dramma non suo, “The Book of Sir Thomas More”, databile al 1592-94, opera di Anthony Munday, con la collaborazione di Henry Chettle, Thomas Dekker, Thomas Heywood e appunto Shakespeare, che non aggiunse mai le scene perché fu bloccata dalla censura (se ne veda l’edizione curata da Giorgio Melchiori e Vittorio Gabrieli, Manchester 1990): Il reperto, pur di indubbio interesse, non getta tuttavia gran luce sui modi in cui il nostro autore lavorava nello stendere i suoi drammi.
E per secoli ha aleggiato nella critica un mito alquanto inverosimile, quello per cui la mano di Shakespeare fosse dotata di una facilità quasi divina. Nel loro appello ai lettori, premesso alla prima edizione quasi completa delle sue opere, il primo In folio del 1623, i curatori, e già attori della sua compagnia, John Heminges e Henry Condell, testimoniavano che “ la sua mente e la sua mano andavano di pari passo”; e il suo collega drammaturgo, Ben Jonson, annotava nei suoi taccuini di aver saputo dagli attori di Shakespeare che “nei suoi scritti, qualsiasi cosa buttasse giù, non ne cancellava mai neanche un rigo”, e aggiungeva sarcastico: “ La mia risposta è stata, ne avesse cancellati un migliaio”. In assenza di manoscritti queste dichiarazioni hanno fatto per lungo tempo pensare che Shakespeare scrivesse di getto e non modificasse più sostanzialmente le proprie opere. Rimaneva tuttavia un inciampo di fronte a tale credenza quasi mistica in una scrittura immediata e definitiva. Di quasi una ventina dei suoi drammi erano state infatti pubblicate edizioni singole, in formato in quarto, già a partire dagli anni 90 del Cinquecento: e in quasi tutti i casi il confronto tra le versioni In folio del 1623 e quelle precedenti mostrava differenze non solo sul piano delle molte varianti morfologiche, lessicali e sintattiche ma anche su quello della stessa struttura drammaturgica.
Come spiegare tali discrepanze? Fino a pochi decenni fa i filologi e, con loro, i critici continuavano a credere, nonostante tutto, che Shakespeare avesse scritto una versione definitiva di ogni suo dramma, le cui variazioni nelle prime edizioni a stampa sarebbero state dovute a errori di composizione o a manipolazioni non autoriali, talchè il compito della filologia doveva essere quello di ricostruire quella versione originaria. La recentissima “New Philology” ritiene, invece, che quei drammi non furono mai stabiliti dall’autore una volta per tutte, ma furono da lui rivisti più volte: erano testi teatrali, mobili per eccellenza, e sottoposti a continue possibili modifiche, nonché a possibili corruzioni e interpolazioni nel corso delle varie messe in scena .La purezza dell’originale, secondo questa nuova prospettiva, va dimenticata una volta per tutte.
Il caso di Amleto è poi del tutto particolare, in quanto è l’unico dramma di cui ci restano ben tre versioni d’epoca. Fino al 1823 se ne conoscevano solo due, quella pubblicata in edizione in quanto nel 1604-5 ( e ristampata con poche varianti, nello stesso formato, nel 1611 e nel 1622 e quella — in parte diversa, a causa di tagli e aggiunte, oltre che di molte varianti morfologiche e lessicali — apparsa nell’In folio del 1623. E i grandi filologi settecenteschi avevano già avuto il loro daffare nello stabilire il testo presuntivamente più vicino all’originale dell’autore oppure alle sue “intenzioni finali” . Ma in quell’anno dell’Ottocento fu fatta una scoperta che mise a rumore il mondo di tutti gli studiosi e gli appassionati di Shakesspeare.
Un certo Sir Henry Bunbury rinvenne in uno stanzino della sua casa di Barton un vecchio volumetto mancante dell’ultima pagina: si trattava di un Amleto pubblicato nel 1603, e dunque prima della prima edizione fino allora conosciuta del dramma. Il frontespizio attribuiva l’opera a Shakespeare e ne indicava una già lunga vita teatrale in rappresentazioni fatte sia a Londra che a Cambridge , Oxford e altrove. Ce n’era abbastanza per incuriosire chiunque , soprattutto perché il testo differiva vistosamente da due fino allora conosciuti. Si sviluppò subito un acceso dibattito sulla sua natura. Si trattava di una prima stesura d’autore: (caso unico in tutto il canone shakespeariano ) o, anche, di una riscrittura giovanile di quel dramma su Amleto, il cosiddetto Ur-Hamlet, da molti attribuito a Thomas Kyd, l’autore della tragedia spagnola) che indubbie testimonianze d’epoca fanno risalire almeno al 1589, ben una dozzina d’anni prima della probabile stesura dell’Amleto classico ? O era da considerarsi un testo piratesco, stenografato durante le rappresentazioni del dramma, o malamente ricostruito a memoria da un attore minore della compagnia, che l’avrebbe venduto sottobanco all’editore? L’unica cosa certa era che quel “primo” Amleto (che tale è, almeno per precedenza cronologica) presentava un’opera molto più breve delle successive due, più rozza, più elementare e, se si vuole, barbarica, mal composta e forse in alcuni passi corrotta, ma dotata di una sua coerenza drammaturgica ed indubbia forza teatrale.
In più punti mostra un diverso montaggio delle azioni. Per fare solo un esempio, la scena -dell’Essere, o non essere- (atto III, scena prima dell’Amleto classico) , cui segue l’incontro tra Amleto e Ofelia, provocato ad arte e spiato da Polonio e dal re per appurare se la follia di Amleto sia davvero follia d’amore, in questo “primo” Amleto ha luogo, coerentemente, subito dopo la “scoperta” di Polonio (che qui, tra l’altro, si chiama Corambis; e altri nomi sono diversi o modificati), mentre nei testi classici viene dopo la lunghissima e seconda scena del II atto .
Alle variazioni delle sequenze drammaturgiche si aggiungono le diverse caratterizzazioni dei personaggi. Il “giovane” Amleto, come in più punti viene definito, è un ventenne mentre negli altri due testi la sua età risulta stranamente spostata ai tremt’anni , e i suoi monologhi, se già ne segnalando lo spaesamento e la vana ricerca di un ruolo e di un senso, appaiono diversamente argomentati (come nell’-Essere, o non essere-) e abbondano di anacoluti e di improvvisi scarti del pensiero.
Quanto al re, appare più unilaterale, più rozzo, e, se possibile, più cattivo. La regina è, invece, meno ambigua, e quindi più innocente, cosicchè nella scena culminante con Amleto può dirsi all’oscuro dell’assassinio del marito e schierarsi decisamente dalla parte del figlio affinchè ne vendichi la morte.
Più coerente per certi aspetti, ma anche più approssimativo, e certo molto inferiore ai due testi classici, questo fantasma testuale ricomparso dopo più di due secoli sembra reclamare a tutt’oggi che si faccia i conti con la sua paternità.
Dal momento della sua scoperta fino a oggi innumerevoli studiosi hanno cercato di risolvere il “giallo” filologico-critico; ma sembra ben difficile che si possa mai chiudere il caso. Troppo incerti, e spesso contraddittori sono gli elementi di cui si deve tenere conto: dati documentali disparati, attestazioni più o meno credibili, riscontri bibliografici dubbi, indizi macro testuali, micro testuali e interstuali interpretabili ad libitum.
L’opera è composita, in più punti quasi un palinsesto va studiata in sé e per sé ma inevitabilmente reclama anche un confronto serrato con i due testi più autorevoli. La critica testuale si trova di fronte a un enorme puzzle, in cui sembra impossibile far combaciare tutti i pezzi in modo che ne emerga la figura dimostrativa inconfutabile. Pertanto, tutti quelli che vi si sono confrontati non hanno potuto fare altro che gli avvocati di parte, ognuno con la sua linea argomentativa di difesa o di accusa; e non si è ancora presentato alcun giudice in grado di emettere un verdetto definitivo.
Proseguendo nella metafora giudiziaria, questo testo è da molti ritenuto “colpevole” in quanto rabberciature dell’opera completa perpetrata da un reporter senza scrupoli, mentre da altri viene considerato “innocente” in quanto prima abbozzo del capolavoro. Anch’io sono stato attirato dentro a questo mistero testuale. All’inizio, la mia posizione è stata quella di semplice spettatore della grande querelle. Ma, man mano che approfondivo l’indagine, mi sono sentito quasi costretto a prendere partito, e, pur non pretendendo di avere scoperto a mia volta dati inconfutabili, ho optato per l’ipotesi della prima stesura autoriale (non importa se condotta su un dramma precedente).
A quel punto, ho ritenuto che il modo migliore di verificare la sensatezza intrinseca di questo testo fosse proprio quello di tradurlo, e conseguentemente di annotarlo, per cercare di carpirne in un’altra lingua i segreti. Tradurre un testo drammatico vuol dire affrontarne non soltanto la semantica discorsiva, ma anche il senso scenico implicito, e cioè la correlazione tra la parola e la mimica, la gestualità, l’azione. Ed è stato proprio alla luce della sua teatralità che questo testo mi è sembrato mostrare, anche nei passi più confusi e corrotti, una sua sostanziale coerenza, una sua autonomia e una sua arcaica bellezza.
Con ciò non intendo dire che tutto fili liscio, né che non si profili qua e là una manipolazione esterna. Ma sta proprio nelle zone d’ombra che ripropone, oltre qualsiasi argomentazionie filologica-critica, il fascino persistente di questo testo. E’ una versione comunque efficace (come hanno dimostrato alcune sue recenti rappresentazioni in Inghilterra, Stati Uniti e Svezia) di una delle più celebri opere drammatiche, una versione che forse costituisce l’unico reperto che possa rivelarci, visto che ci mancano i suoi manoscritti, come lavorava la mente di Shakespeare nella fase embrionale di un capolavoro.” (da: “Il dilemma di due Amleti,” — di Alessandro Serpieri su:“Il Sole 24 ore”- del 18/ 05/ 1997 )
EDGAR LEE MASTERS
L’Antologia di Spoon River”(1916) di Edgar Lee Masters, è la più originale opera poetica che ha avuto generazioni di lettori, nonostante sia stato definito “un libro di morti”. In verità, è il più bell’esempio di confessione e rivelazione di fatti e misfatti raccontati, anche ironicamente, da una folla illustre e anonima di cari estinti di un piccolo paese americano, che fanno conoscere il loro passato in forma di epitaffi sulla collina di “Spoon River”, dove i vivi si danno appuntamento per conoscere o “leggere “le “storie” di Charlie French, del giudice Somers, di Aner Clute o di Francis Turner. Complessivamente l’opera si compone di 244 poesie e ogni testo è la “voce” di un trapassato , che si rammarica della propria esistenza o maledice chi l’ha portato alla tomba. Non vi è nulla che possa ricondurre l’opera ad una atmosfera lugubre e tetra. Tutto il resoconto narrativo, che proviene come — fiction — dall’aldilà, è un discorso “spirituale” che si riflette sulla condizione umana mettendone in evidenza difetti e violenze.
CHARLIE FRENCH
Avete mai scoperto
chi dei ragazzi O’Brien sia stato a spararmi
nella mano con la pistola giocattolo?
Là, quando le bandiere erano rosse e bianche
nella brezza e “Bucky” Estil
sparava il cannone portato da Viksburg
a Spoon River dal capitano Harris,
e i chioschi delle limonate erano aperti
e la banda suonava,
tutto fu rovinato
per una scheggia di una cartuccia
scoppiata sotto la pelle della mia mano,
e i ragazzi accalcati intorno a me dicevano:
“Morirai di tetano, Charlie, di sicuro!.
Oh Dio! Oh, Dio!
Quale dei miei compagni ha potuto fare questo?
IL GIUDICE SOMERS
Come si spiega, ditemi,
che io, il più erudito degli avvocati,
che conoscevo Blackstone e Coke
quasi a nemoria, che pronunciai la più bella arringa
che mai la Corte avesse udito, e scrissi
un esposto che meritò l’elogio del giudice Breese —
come si spiega, ditemi,
che io giaccio qui senza un segno, dimenticato,
mentre Chase Henry, l’ubriacone del paese,
ha un cippo di marmo, con sopra un’urna,
dove la Natura con irridente malizia,
ha fatto crescere una malerba tutta fiorita?
THEODORE, IL POETA
Da ragazzo, Theodore, sedevi per lunghe ore
sulla sponda del torbido Spoon
con lo sguardo immobile a fissare il buco
della tana del gambero,
in attesa che apparisse, spingendo avanti,
prima le sue antenne ondeggianti, come fili di fieno,
e poi il suo corpo, color steatite,
gemmato con occhi di giaietto.
E ti chiedevi assorto nel pensiero
che cosa sapesse, cosa desiderasse, e perché mai avesse.
Ma più tardi il tuo sguardo prese a scrutare uomini e donne
nascosti nelle tane di perdizione in mezzo alle grandi città,
in attesa che le loro anime uscissero,
così da poter vedere
come vivessero, e per che cosa,
e perché strisciassero così indaffarati
lungo la strada sabbiosa dove l’acqua manca
quando l’estate si dilegua.
ANER CLUTE
Più e più volte mi chiesero,
mentre mi pagavano birra o vino,
prima a Peoria e poi a Chicago,
Denver, Frisco, New York, dove vissi,
perché mai divenni una ragazza di vita,
e come avessi cominciato,
Bene, dicevo, per un abito da sera,
e la promessa di matrimonio d’un ricco signore —
(era Lucius Atherton).
Ma le cose non stavano così.
Immaginate che un ragazzo rubi una mela
dal cesto del droghiere,
e tutti incomincino a chiamarlo ladro,
il giornalista, il prete, il giudice e tutta la gente —
“ladro”, “ladro”, “ladro”, dovunque vada.
E non può avere un lavoro, né procurarsi il pane
se non rubando, perciò, quel ragazzo ruberà.
E’ come la gente considera il furto della mela
che rende il ragazzo quello che è.
FRANCIS TURNER
Non potevo né correre né giocare
da ragazzo.
Da adulto potevo soltanto sorseggiare dalla coppa,
non bere-
perché la scarlattina mi aveva lasciato il cuore malato.
Eppure giaccio qui
confortato da un segreto che solo Mary conosce
c’è un giardino di acacie,
di catalpe, di pergole dolci di viti-
là quel pomeriggio di giugno
al fianco di Mary-
baciandola con l’anima sulle labbra
d’improvviso l’anima prese il volo.
LA COLLINA
Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley,
il debole di volontà, il forte di braccia,
il buffone, il beone, il rissoso?
Tutti, tutti, dormono sulla collina.
Uno morì di febbre,
uno arse nella miniera,
uno fu ucciso in una rissa,
uno spirò in galera,
uno cadde da un ponte faticando per moglie e figli —
Tutti, tutti, dormono, dormono sulla collina.
Dove sono Ella, Kate, Mag, Lizzie, e Edith,
il cuore sensibile, l’anima candida, la rumorosa,
l’orgogliosa, la felice? —
Tutte, tutte, dormono sulla collina,
Una morì di parto vergognoso,
una di amore contrastato,
una per mano di un bruto in un bordello,
una d’orgoglio infranto inseguendo la follia del cuore,
una dopo una vita, lontano, a Londra e Parigi
fu riportata al suo piccolo spazio vicino a Ella, Kate e Mag —
Tutte, tutte, dormono sulla collina.
Dove sono zio Isaac e zia Emily,
e il vecchio Touny Kincaid e Sevigne Houghton,
e il maggiore Walker che aveva parlato
con uomini venerabili della rivoluzione ? —
Tutti, tutti, dormono sulla collina.
Li riportarono figli morti dalla guerra,
e figlie prostrate dalla vita,
e i loro bimbi orfani, in pianto —
Tutti, tutti, dormono dormono, dormono sulla collina.
Dov’è Jones, il vecchio violinista
che giocò con la vita tutti i suoi novant’anni,
sfidando il nevischio a petto nudo,
bevendo, strepitando
non pensando né a moglie né a famiglia,
né all’oro, né all’amore, né al cielo?
Eccolo! Ciancia di pesce fritto d’altri tempi,
delle corse di cavalli di tanti anni fa
al boschetto di Clary,
di ciò che Abe Lincoln
disse una volta a Springfield.
ZENAS WITT
Avevo sedici anni e facevo sogni orribili,
e avevo macchie davanti agli occhi e nervi scossi.
E non riuscivo a ricordare i libri che leggevo,
come Frank Drummer che imparava a memoria
pagine su pagine.
E la mia schiena era debole e mi tormentavo e tormentavo,
ero confusa e balbettavo le lezioni,
e quando mi alzavo per recitarle, dimenticavo
quello che avevo studiato.
Bene, vidi l’annuncio del dottor Weese,
e là lessi stampato tutto,
proprio come se mi avesse conosciuto;
anche i sogni di cui non riuscivo a liberarmi.
Così seppi che ero destinata a morire giovane.
E mi tormentavo finchè presi una tosse,
e allora i sogni cessarono.
E poi dormii un sonno senza sogni
qui sulla collina presso il fiume.
JUAN RAMON JIMENEZ
La poesia solare di Jiménez, con le sue arditissime analogie e il ritmo incalzante del verso, trova momenti di sinceri agganci con l’Assoluto, non disgiunti da umbratili riflessioni di fronte al pensiero della morte, mentre lo spirito del poeta nostalgicamente vaga nel “giardino fiorito”, in una poesia dalla prospettiva “visionaria” dove a sopravvivere fisicamente sembrano essere la natura e il ciclo delle stagioni, come nel bellissimo testo: “Il viaggio definitivo” da: ”La stagione totale”(1923-1939)
“… E io me ne andrò. E resteranno gli uccelli / a cantare /e resterà/ il mio orto, col suo verde albero / e col suo pozzo bianco /. Tutte le sere , il cielo sarà azzurro e placido; / e suoneranno, come questa sera stan suonando, / le campane del campanile. / Moriranno quelli che mi amarono; / e il paese si rinnoverà ogni anno; / e in quell’angolo del mio orto fiorito e bianco di calce / il mio spirito errerà, nostalgico…./ E io me ne andrò; e sarò solo, senza focolare, senz’albero / verde senza pozzo bianco, / senza cielo azzurro e placido …/ E resteranno gli uccelli a cantare./
THOMAS STEARNS ELIOT
Non estraneo ad una concezione cristiana della vita è il pensiero di T.S. Eliot che con la sua opera poetica dà slancio e vitalità ad una visione del mondo non priva di riferimenti salvifici. Il canto di Eliot è un continuo indagare e perlustrare sui segni della vita, che quantunque negativi, spianano la via ad una sofferta e rasserenante opzione religiosa. Notevoli sono gli accumuli psicolinguistici che, provenienti dalla conoscenza di diverse letterature, da quella medievale di Dante e Cavalcanti, a quella angloamericana, di Emerson, Melville, Hawthorne e Poe, con una fitta sedimentazione conoscitiva di messaggi filosofici recepiti dai discorsi di George Santayana e di Henri Bergson, fanno di Eliot il massimo rappresentante di una poetica nella quale il rapporto tra i vivi e i morti non diventa mai distacco o frattura, ma continuità dell’esistenza. La sua ricerca etico-morale è sofferta e dilacerante e si pone sul versante della liberazione spirituale dove le poesie costituiscono un unico corollario storico , ovvero “ una vivente unità di tutte le poesie “, che sono state scritte nel corso dei tempi .
Da qui la concezione di una poetica “universale”, che accentra nel suo interno riferimenti ed echi di più autori, innesti verbali provenienti dalla liturgia ecclesiale, reminiscenze shakespeariane e duecentesche, e che coinvolge l’uomo dall’angoscia della “Terra desolata”, alla speranza cristiana del “Mercoledì delle Ceneri” .
Di questa poetica importante è la correlazione tra l’esistenza e l’inesistenza. E in “Four Quartets” si rilevano momenti di fervore cristiano di notevole rilievo.
Le domande, i dubbi e gli insistenti richiami alla Salvezza dopo la morte accentuano il carattere unitario di una poesia, che avverte il male di vivere e ne analizza a fondo gli aspetti negativi denunciati nelle loro sequenze fenomenologiche. senza smarrimenti, attraverso l’adozione di un sapiente simbolismo cristiano che supera il trionfo stesso della morte laddove essa è proclamata con vigore, ma senza resa, come nel testo “Il viaggio dei Magi”- “Per noi questa Nascita fu / Come un’aspra ed amara sofferenza, come la Morte, la nostra Morte” -, mentre ne il “Mercoledì delle Ceneri” si fa forte il senso della pietà per tutto il genere umano: “Prega per noi peccatori ora e nell’ora della nostra morte/ Prega per noi ora e nell’ora della nostra morte/,” lasciando a Dio l’ultima chance e alla preghiera il senso estremo della consolazione: “E prego Dio che abbia pietà di noi/ E prego di poter dimenticare/ Queste cose che troppo/ Discuto con me stesso e troppo spiego/”svelando nel testo: ”La sepoltura dei morti” aperture e confini del nostro limite temporale.
CANTO DI SIMEONE
Signore, i giacinti romani fioriscono nei vasi
E il sole dell’inverno s’insinua sui colli di neve;
La stagione ostinata si sofferma.
La mia vita è leggera, in attesa del vento di morte,
Come una piuma sul dorso della mano.
La polvere nel sole e la memoria negli angoli
Attendono il vento che gela verso la terra morta.
Concedi a noi la tua pace.
Per molti anni camminai in questa città,
Mantenni fede e digiuno, provvedetti ai poveri,
Ho dato e avuto onori e agiatezza.
Chi giunse alla mia porta non fu mai respinto.
Chi si ricorderà della mia casa, dove vivranno i figli dei
miei figli,
Quando verrà il tempo del dolore?
Prenderanno il sentiero della capra, la tana della volpe,
Fuggendo i volti stranieri e le spade straniere.
Prima che venga il tempo delle corde, delle sferze e dei
Lamenti
Concedi a noi la tua pace.
Prima delle stazioni della montagna di desolazione,
Prima dell’ora certa del dolore materno,
Ora in questa stagione di nascita e morte,
Possa il Figliolo, il Verbo non pronunciante e impronunciato
ancora ,
Accordare la consolazione d’Israele
A un uomo di ottant’anni e che non ha domani.
Secondo la tua parola
Ti loderanno e soffriranno a ogni generazione
Con gloria e derisione,
Luce su luce, salendo la scala dei santi.
Non per me il martirio, l’estasi del pensiero e della preghiera,
Non per me la visione estrema.
Concedi a me la tua pace.
(E una spada trafiggerà il tuo cuore,
Anche il tuo.)
Sono stanco della mia vita e della vita di quelli che verranno,
Muoio della mia morte e della morte di quelli che verranno.
Che il tuo servo si parta,
Dopo aver visto la tua salvezza.
LA SEPOLTURA DEI MORTI
Aprile è il mese più crudele, genera
Lillà da terra morta, confondendo
Memoria e desiderio, risvegliando
Le radici sopite con la pioggia della primavera.
L’inverno ci mantenne al caldo, ottuse
Con immemore neve la terra, nutrì
Con secchi tuberi una vita misera.
L’estate ci sorprese, giungendo sullo Starnbergersee
Con uno scroscio di pioggia, noi ci fermammo sotto il colonnato,
E proseguimmo alla luce del sole, nel Hofgarten,
E bevemmo caffè, e parlammo un’ora intera.
Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.
E quando eravamo bambini stavamo presso l’arciduca,
Mio cugino, che mi condusse in slitta,
E ne fui spaventata. Mi disse, Marie,
Marie, tieniti forte. E ci lanciammo giù.
Fra le montagne, là ci si sente liberi.
Per la gran parte della notte leggo, d’inverno vado nel sud.
Quali sono le radici che s’afferrano, quali i rami che crescono.
Da queste macerie di pietra? Figlio dell’uomo,
Tu non puoi dire, né immaginare, perché conosci soltanto
Un cumulo d’immagini infrante, dove batte il sole,
E l’albero morto non dà riparo, nessun conforto lo stridere del grillo,
L’arida pietra nessun suono d’acque.
C’è solo ombra sotto questa roccia rossa,
(Venite all’ombra di questa roccia rossa),
E io vi mostrerò qualcosa di diverso
Dall’ombra vostra che al mattino vi segue a lunghi passi,
o dall’ombra
Vostra che a sera incontro a voi si leva;
In una manciata di polvere vi mostrerò la paura.
Frish weht der Wind
Der Heimat zu
Mein Irisch Kind,
Wo weilest du?
Fu un anno fa che mi donasti giacinti per la prima volta;
Mi chiamarono la ragazza dei giacinti…
Eppure quando tornammo, a ora tarda, dal giardino dei giacinti,
Tu con le braccia cariche, con i capelli madidi, io non potevo
Parlare, mi si annebbiavano gli occhi, non ero
Né vivo, né morto, e non sapevo nulla, mentre guardavo
il silenzio,
Il cuore della luce.
Oed’ und leer das Meer.
Madame Sosostris, chiaroveggente famosa,
Aveva preso un brutto raffreddore, ciononostante
E’ nota come la donna più saggia d’Europa,
Con un diabolico mazzo di carte . Ecco, qui ,disse,
La vostra carta, il Marinaio Fenicio Annegato
(Quelle sono le perle che furono i suoi occhi. Guardate)
E qui è la Belladonna, la Dama delle Rocce,
La Dama delle situazioni.
Ecco qui l’uomo con le treaste, ecco la Ruota,
E qui il Mercante con un occhio solo, e questa carta,
Che non ha figura, è qualcosa che porta sul dorso,
E che a me non è dato vedere. Non trovo
L’impiccato. Temete la morte per acqua.
Vedo turbe di gente che cammina in cerchio.
Grazie. Se vedete la cara Mrs. Equitone,
Ditele che le porterò l’oroscopo io stessa:
Bisogna essere così prudenti in questi giorni.
Città irreale,
Sotto la nebbia bruna di un’alba d’inverno,
Una gran folla fluiva sopra il London Bridge, così tanta,
Ch’i non avrei mai creduto che morte tanta n’avesse disfatta.
Sospiri, brevi e infrequenti, se ne esalavano,
E ognuno procedeva con gli occhi fissi ai piedi. Affluivano
Su per il colle e giù per la King William Street,
Fino a dove Saint Mary Woolnoth segnava le ore
Con morto suono sull’ultimo tocco delle nove.
Là vidi uno che conoscevo, e lo fermai, gridando: “Stetson!
Tu che eri a Mylae con me, sulle navi!
Quel cadavere che l’anno scorso piantasti nel giardino,
Ha cominciato a germogliare? Fiorirà quest’anno?
Oppure il gelo improvviso ne ha danneggiato l’aiola?
Oh, tieni il Cane a distanza, che è amico dell’uomo,
Se non vuoi che con l’unghie, di nuovo , lo metta allo scoperto!
Tu hypocrite lecteur ! — mon semblable – mon frère!
GIOSUE’ CARDUCCI
Nel 1848 la letteratura italiana, tra classicismo e romanticismo, rivoluzione e impegni di guerre, si indirizza contro la tirannide straniera attraverso le più genuine richieste di libertà espresse dal popolo. La poesia diventa occasione di incitamento alla realizzazione di nuovi ideali. Ma dopo le prime inevitabili sconfitte per la liberazione, la letteratura si eclissa silenziosamente dagli impegni civili e politici attestandosi su una produzione letteraria, sentimentale e languorosa, fino a quando, contro gli ultimi singulti del romanticismo, non appare sulla scena culturale Giosuè Carducci, che forte della sua passione civile e nazionale, diventa paladino della tradizione, riproponendo ad esempio l’opera di Dante e di Virgilio. Dall’austero e ribelle poeta delle “Odi barbare” de “l’Inno a satana” e di “Giambi ed epòdi” non mancano prove poetiche di pensosa meditazione e riflessione come in “Juvenilia”: “ Passa la nave mia , sola, tra il pianto / de gli alcion, per l’acqua procellosa;” e in “Levia Gravia”: “O tu che dormi là su la fiorita /collina tòsca, e ti sta il padre a canto ; / non hai tra l’erbe del sepolcro udita / pur ora una gentil voce di pianto? / E’ il fanciulletto mio , che a la romita / tua porta batte; ei che nel grande e santo / nome te rinnovava, anch’ei la vita / fugge, o fratel, che a te fu amara tanto./ /. Ma è con “Rime nuove” e con il sonetto “Funere mersit acerbo”, che la poesia carducciana lascia tracce indelebili del dolore, come in “Pianto antico”, e “Davanti San Guido”
PIANTO ANTICO
L’albero a cui tendevi
la pargoletta mano,
il verde melograno
da’ bei vermigli fior,
nel muto orto solingo
rinverdì tutto or ora,
e giugno lo ristora
di luce e di calor.
Tu fior de la mia pianta
percossa e inaridita,
tu de l’inutil vita
estremo unico fior,
sei ne la terra fredda,
sei ne la terra negra;
né il sol più ti rallegra
né ti risveglia amor.
GIOVANNI PASCOLI
Il Decadentismo europeo accogliendo alcuni aspetti formali della poetica simbolista, trova in Giovanni Pascoli il “fanciullino” freudiano che, con ”Myricae” e i “Canti di Castelvecchio”, inaugura una stagione poetica di romagnola solarità e di brividi novembrini.
I riferimenti metaforici visti nel loro naturale rapporto con le stagioni, costituiscono la mappa di un discorso che sottintende il grande problema del Bene e del Male. Alcuni temi della liturgia cristiana, come il Natale, la Pasqua e il culto dei morti, finiscono con l’essere materiale simbolico nelle cadenze del tempo all’interno di una scenografia spirituale che ha come sfondo la storia delle sue tragedie familiari, come momento egemone di un discorso sempre più espressivo e figurato all’interno del quale si pongono il poeta adulto e il “fanciullino”, ovvero l’altro di sé del poeta smarrito e stupito di meraviglia di fronte al mondo delle cose prima della loro contaminazione e dissolvenza.
Si veda, per esempio il testo dal titolo “Nebbia” che racchiude i caratteri peculiari della sua poetica come il rifiuto-rigetto del passato in quanto espressione di lutto e di dolore, la suggestione-contemplazione della natura e infine la riappropriazione del pensiero della morte come evento ineluttabile di tutto il genere umano:
-”Nascondi le cose lontane,/tu nebbia impalpabile e scialba,/ tu fumo che ancora rampolli,/ su l’alba,/ da’ lampi notturni e dà crolli/ d’aeree frane!…..Nascondi le cose lontane:/ le cose son ebbre di pianto! Ch’io veda i due peschi, i due meli soltanto/ che danno i soavi loro mieli/ pel nero mio pane./…. Nascondi le cose lontane / che vogliono ch’ami e che vada! Ch’io veda là solo quel bianco/ di strada, / che un giorno ho da fare tra !stanco/ don don di campane…./ – mentre nel testo dal titolo “Di là” fluiscono, opponendosi l’uno all’altro, i segni della comparazione di due mondi: l’uno solare, e l’altro, silenziosamente cupo e abbandonato.
DI LA’
L’entrata era aperta, nel sole,
sopra anditi pallidi e lunghi.
Di fuori era odor di viole:
ma dentro, di muffa e di funghi.
Qua prati, là via senza capi,
qua zolle, là squallidi tufi.
Di fuori ronzavano l’api,
ma dentro soffiavano i gufi.
Veniva di qua, mattiniero,
lo strido di rondini folte;
di là, di laggiù, da quel nero,
un suon di campane sepolte.
Entrasti….. fra cespi d’assenzio,
cogliendoti un non-ti-scordare-di-me…..
La porta col blando silenzio
dell’olio t’udisti serrare su te.
o ancora nel testo “L’aquilone”, che rievoca speranze e illusioni e colpisce per quel senso di amara conclusione di fronte alla morte:” Meglio venirci ansante, roseo, molle/ di sudor, / come dopo una gioconda / corsa di gara per salire un colle!” e in “La mia sera” dove , tra pensosa meditazione e senso vivissimo di una antica felicità, l’anima si ricompone e si disperde in un dolce nulla:
“ Il giorno fu pieno di lampi; / ma ora verranno le stelle, / le tacite stelle…..Nel giorno, che lampi! Che scoppi! / Che pace la sera!…..e che nella quinta strofa finale s’apre a sorprendenti effetti di obnubilamento” Don… don……E mi dicono, Dormi! / mi cantano, Dormi!, sussurrano, / Dormi, bisbigliano, Dormi! / là voci di tenebra azzurra…/ Mi sembrano canti di culla, che fanno ch’io torni com’era…/ sentivo mia madre… piò nulla…/ sul far della sera./
La poesia di Pascoli va vista soprattutto nel duplice rapporto dicotomico tra mondo reale e mondo immaginario. L’uno, erogatore di immagini cupe e ostili, l’altro, produttore di visioni estatico-contemplative in un microcosmo rurale e naturalistico dove la memoria subentra e domina come una musa larica.
A determinare questo stato di grazia e di contemplazione è sempre la figura metaforica del “fanciullino” che carica su di sé tutta l’innocenza perduta, in una visione del Mondo che, quantunque contaminata dal Male, resta la fonte di infinite trasposizioni emotive e psicologiche e di genuine indicazioni che portarono il poeta a guardare le cose circostanti con occhi innocenti e a riconoscere nella madre una delle fonti principali della sua sensibilità poetica dichiarata nella Prefazione ai “Canti di Castelvecchio”:
“Io sento che a lei devo la mia abitudine contemplativa, cioè, quel ch’ella sia, la mia abitudine poetica. Non posso dimenticare certe sue silenziose meditazioni in qualche serata, dopo un giorno lungo di faccende, avanti i prati della Torre. Ella stava seduta sul greppo: io appoggiavo la testa sulle sue ginocchia. E così stavamo a sentir cantare i grilli e a vedere soffiare i lampi di caldo all’orizzonte. Io non so più a che cosa pensassi allora: essa piangeva. Pianse poco più di un anno, e poi morì”.
Questo stato d’animo poetico-contemplativo, lo troviamo costantemente in Myricae dove meglio si configurano le proiezioni spirituali del poeta con l’ambiente esterno oscillante tra simbolo e realtà. Si ved ad esempio la poesia “L’assiuolo” che meglio testimonia un’atmosfera dai contorni sfumati, sullo sfondo notturno di un ambiente surreale nel quale domina la presenza costante e ripetitiva del pianto di un uccello, come a scandire ritmi e tempi di una vita cosmica e terrena nella quale i termini psicologici di una condizione esistenziale sono visti tra mistero e morte, senso del finito e dell’infinito.
L’ASSIUOLO
Dov’era la luna? che il cielo
notava in un’alba di perla,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederla.
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù;
veniva una voce dai campi
chiù…
Le stelle lucevano rare
tra mezzo alla nebbia di latte:
sentivo il cullare del mare,
sentivo un fru fru tra le fratte;
sentivo nel cuore un sussulto,
com’eco d’un grido che fu.
sonava lontano il singulto:
chiù…
Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro di vento;
squassavano le cavallette
finissimi sistri d’argento
(tintinni a invisibili porte
che forse non s’aprono più?..
e c’era quel pianto di morte:…
chiù
Seconda parte
LE ANAMNESI DIFFERENZIATE SUL NULLA/MORTE
Il Novecento italiano col suo ampio repertorio letterario sul tema del nostro essere — qui e ora – offre un flusso ininterrotto di testi che, se non rimuovono totalmente le domande sul senso della vita, prospettano anamnesi differenziate dell’interrogazione esistenziale, con interessanti margini di interpretazione proiettati su alcuni momenti riflessivi e meditativi, tra dialogo e soliloquio, per una dialettica sulla morte, legata in larga misura al ricordo dei cari estinti e ad una forte e marcata problematica esistenziale come in Montale, Sereni, Luzi, Pavese e Caproni, che hanno autorevolmente segnato il loro cammino con opere che riflettono il destino dell’uomo e della sua fragilità, anche attraverso un’appassionata ricerca etico-morale, fortemente combattuta, fino all’estremo (ir)razionale gesto del suicido in Carlo Michelstaedter il quale, nella continua lotta tra spirito e ragione, recupera con la poesia la strada dei suoi meandri esistenziali e la luce vivissima del suo processo di liberazione: “Lasciami andare , Paula, nella notte, / a crearmi la luce da me stesso, / lasciami andare oltre il deserto, al mare; / perch’io ti porti il dono luminoso”. Alcuni documenti poetici provenienti dal Crepuscolarismo, a parte Corazzini che vede nella Morte la fine dei suoi mali fisici nella composizione dal titolo: la “Desolazione del povero poeta sentimentale” Perché tu mi dici : poeta?/ Io non sono un poeta./Io non sono che un piccolo fanciullo che piange./ Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio./Perché tu mi dici: poeta? ……” io so che per essere detto: poeta , conviene / viver ben altra vita! Io non so , Dio mio, che morire “, fanno parte di un più ampio archivio di sentimenti ed emozioni come in Guido Gozzano che, accanto ad una descrizione provinciale e ironica della vita di provincia, ci trasmette una visione della morte (senza querele) portatrice di benessere e di dolce (sapore),definita la grande (eguagliatrice), o ancora in Camillo Sbarbaro che, attraverso un colloquiare dimesso e a bassa voce, alza i toni del ricordo, magnificando la figura del padre in “Pianissimo ”Padre, se anche tu non fossi il mio/ Padre”/, per te stesso ugualmente t’amerei/, portando al limite del prosaicismo lirico gestualità affettive e memorie incancellabili.
In molti poeti l’atteggiamento correlato alle stagioni dell’autunno e dell’inverno, che meglio esprimono metaforicamente le età mature della vita rievocate tra delusioni e inganni, tra sogni e luoghi della memoria, è spesso sentimento di difficoltà nel cercare varchi di salvezza al di là di ogni inconfessabile dubbio davanti all’imperscrutabile. Ecco allora la scelta di correlativi oggettivi nel tempo che passa e nella stagione che scolora o che annulla la visione dell’orizzonte con elementi fisici quali la pioggia, la nebbia e la neve. E’ la metafora della desolazione della vita e di un male di vivere portati al limite di una tensione spirituale sincera e fortemente elegiaca come in questi testi dal titolo “Autunno” di Vincenzo Cardarelli e di Adriano Grande e in “Fuga di giovinezza” di Hermann Hess.
VINCENZO CARDARELLI
AUTUNNO
Autunno. Già lo sentimmo venire
nel vento di agosto,
nelle pioggie di settembre
torrenziali e piangenti,
e un brivido percorse la terra
che ora, nuda e triste,
accoglie un sole smarrito.
Ora passa e declina,
in quest’autunno che incede
con lentezza indicibile,
il miglior tempo della nostra vita
e lungamente ci dice addio.
ADRIANO GRANDE
AUTUNNO
Autunno la tua musica!
Un’uguale tristezza in me discende
a quella che t’avvolge, o età dell’anno
che scendi a morte con mesta allegrezza.
Concedi ch’io mi accordi sui tuoi flauti.
Prestami una tua forma.
Dammi i tuoi frutti accesi :
una vite arrossata; od una pergola
dove io mi stenda e dorma.
Mi cullassero i rami di una quercia,
nei tuoi profumi passeggeri e blandi
si placassero, come a un oppio nuovo,
l’aspro pensiero teso,
il vivere penoso
e l’obbedire inutili comandi.
HERMANN HESSE
FUGA DI GIOVINEZZA
La stanca estate china il capo,
specchia nell’acqua il biondo volto.
Io vado stanco e impolverato
nel viale d’ombra folto.
Soffia tra i pioppi una leggera
brezza. Ho alle spalle il cielo rosso,
di fronte l’ansia della sera
e il tramonto e la morte.
E vado stanco e impolverato
e dietro a me resta esitante
la giovinezza, china il capo
e non vuol più seguirmi avanti.
EUGENIO MONTALE
L’itinerario poetico di Eugenio Montale è tutto un descrittivo tomo intorno al “male di vivere”, che dall’iniziale testo dal titolo: “Meriggiare pallido e assorto” in “Ossi di seppia”, è venuto via via, a fissare i termini di un percorso esistenziale di ansia metafisica e di recupero dei luoghi della memoria, approfonditi nelle successive opere, testimoniando con la sezione “Xenia” del volume “Satura”, il rapporto affettivo con la moglie scomparsa, chiamata “Mosca”:
” Caro piccolo insetto/ che chiamavano mosca non so perché / stasera quasi al buio / mentre leggevo il Deuteroisaia / sei ricomparsa accanto a me , / ma non avevi occhiali, / non potevi vedermi / né potevo io senza quel luccichio / riconoscere te nella foschia
o ancora…
“Al Saint James di Parigi dovrò chiedere / una camera “ singola”(Non amano/ i clienti spaiati) … per poi cercare subito / lo sgabuzzino delle telefoniste, / le tue amiche di sempre, e ripartire, esaurita la carica meccanica, / il desiderio di riaverti, fosse / pure in un solo gesto o un’abitudine./
Il discorso con le ombre è sempre, pudicamente sommesso, volto a recuperare “l’assenza” che per il poeta è richiamo alla vita, pur nella singolare illusione della finzione, attraverso il recupero memoriale del volto, e dei gesti, come estremo rapporto affettivo dei vivi verso i morti.
La poetica montaliana, complessa ed eterogenea di fronte ai fatti della Storia, si è sempre adattata alle domande che più distruttivamente azzerano la ricerca esistenziale dell’uomo, portando su punte di estrema disperazione la ricerca della Verità, tra momenti di ansia religiosa e impennate illuministiche, al fine “ di scoprire uno sbaglio della Natura, / il punto morto del mondo, l’anello / che non tiene, / il filo da disbrogliare che finalmente / ci metta / nel mezzo di una verità./ “ Il suo manifesto poetico, già dichiarato in “meriggiare pallido e assorto” è la dichiarazione della Vita come Nulla.
“Arsenio”, “ I limoni” ,“Stanze”, “Iride”, ”L’orto”, sono soltanto alcuni dei percorsi “aridi” di Montale, che affida alla memoria l’unica via di fuga dal vivere quotidiano.
Luciano Minguzzi, tracciando uno schizzo del poeta sul letto di morte, ci fa vedere un Montale pacificato con le sue inquietudini, con i suoi tremendi quesiti esistenziali, con i suoi dubbi e le sue incertezze, solo, in quel gorgo che accomuna uomini e cose, mentre il “girasole impazzito di luce” si allontana per sempre dal “terreno bruciato dal salino”, ultimo emblema di una felicità e di un possibile barlume che non ci è dato di avere o di scoprire.
Ora che Montale è fuori da questa “amara tortura senza nome”, apprendiamo con sorpresa la sua grande lezione di poesia e di umanità. Il varco o il punto di fuga che Montale ci ha additati, è nella nostra coscienza, nella nostra solidarietà e pietà fuori da ogni turbamento che ci proviene dalla nostra condizione di esiliati incapaci di trovare il senso della vita “che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia”. Come per Giorgio Caproni, poeta della ricerca metafisica, in continua lotta con se stesso e con Dio, che ne “ Il muro della terra” ha mirabilmente scritto: “Ho provato anch’io. / E’ stato tutto una guerra / d’unghie. / Ma ora so. / Nessuno / potrà mai perforare / il muro della terra.” / ; così anche per Montale il doloroso problema del Dio assente o presente, si riaffaccia costante in tutta la sua poetica. “Nelle mie poesie”, ha scritto il poeta, “ho tentato di sperare, di battere al muro, di vedere ciò che poteva esserci dall’altra parte della parete, convinto che la vita ha un significato che ci sfugge. Ho bussato disperatamente come uno che attende una risposta.” E Montale la risposta non l’ha trovata, nessuno gli è venuto incontro, neppure il “Volto insanguinato sul sudario”, come nella bellissima “Iride”, un’altra poesia onirica, dove il poeta si rivela come un maudit, fortemente conscio delle umane ferite e delle profonde contraddizioni del vivere e del morire.
L’umano dolore e il senso estremo della vita sono stati espressi da Montale con ironia e tragedia, in un notturno dolcissimo che ha suggestionato intere generazioni di lettori e di poeti. La sua poesia si è sempre esposta allo scoperto, nei confronti degli inganni e delle illusioni del momento, se il poeta, già a sedici anni, riesce a dare una rappresentazione esatta del mondo e delle cose, come in “meriggiare pallido e assorto”, dove disperazione e senso del Nulla sbarrano la via a qualsiasi ipotesi di fuga o di salvezza.
Nella disgregazione cosmica delle cose, perenne ed eterna, Eugenio Montale si è identificato, ha tracciato il segno effimero delle stagioni, ha mosso con decenza e dignità, la catena del nostro purgatorio quotidiano, con un rigore morale e culturale sul grande tema delle negazioni e dell’esistenza per farci superare la “dannazione” come una “amara oscurità che scende su chi resta”.
“ La poesia di Montale si propone come discorso sulla poesia stessa e sulla sua tradizione e sui suoi segni, ma anche, al tempo stesso, allegoria della condizione umana e del rapporto con la morte e con la sempre più improbabile divinità. Penso a …. “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”, dove c’è la contrapposizione fra l’angelo sceso in terra e le ombre di qui, le solite ombre dei morti (dei morti / vivi, degli uomini ormai ridotti a ombre, ormai coinvolti tutti in una finzione di esistenza fantasmatica), fra il viaggio cosmico fra nebulose e cicloni che ha un che di pascoliano e il vicolo di qui, lo scantonare nel vicolo come unico e infinitamente degradato cammino quale possono compiere le ombre.” (Giorgio Bàrberi Squarotti: La poesia del Novecento”, Salvatore Sciascia Edizioni, Ottobre 1985, pag.220).
TI LIBERO LA FRONTE DAI GHIACCIOLI
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
che raccogliesti traversando l’alte
nebulose; hai le penne lacerate
dai cicloni, ti desti a soprassalti.
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole
freddoloso; e l’altre ombre che scantonano
nel vicolo non sanno che sei qui.
ALFONSO GATTO
Poeta ermetico della seconda generazione, ma con moduli linguistici dichiaratamente meno oscuri e più aperti all’emozione, Alfonso Gatto ha fissato, sin dalla sua prima raccolta dal titolo “Isola”, i parametri poetici dai quali traccerà, in seguito, delle bellissime pagine poetiche, allusive e disincantate, sensuali e malinconiche entro i limiti di una descrizione dell’amore e del ricordo, musicalmente recuperati tra surrealismo e metafora. La sua “isola” è un lembo d’anima nel grande azzardo della vita, che si dilata di fronte alle vicende della resistenza e della guerra con poesie di ampia partecipazione e sofferenza .Cromatismo linguistico e disposizione emozionale al ricordo e all’amore, caratterizzano questa poesia psicoemotiva che si lega e si scioglie, di fronte alla morte, all’interno di una poetica sempre “solare” e “azzurra”, attraversata dall’immagine della “sera”, vista quasi sempre con malinconia e come limite temporale del vivere quotidiano.
A MIO PADRE
Se mi tornassi questa sera accanto
lungo la via dove scende l’ombra
azzurra già che sembra primavera,
per dirti quanto è buio il mondo e come
ai nostri sogni in libertà s’accenda
di speranze di poveri di cielo,
io troverei un pianto da bambino
e gli occhi aperti di sorriso, neri
neri come le rondini del mare.
Mi basterebbe che tu fossi vivo,
un uomo vivo col tuo cuore è un sogno.
Ora alla terra è un’ombra la memoria
della tua voce che diceva ai figli:
“Com è bella la notte e com’è buona
ad amarci così con l’aria in piena
fin dentro al sonno”. Tu vedevi il mondo
nel plenilunio sporgere a quel cielo,
gli uomini incamminati verso l’alba.
PAROLE
“Ti perderò come si perde un giorno
chiaro di festa: – io lo dicevo all’ombra
ch’eri nel vano della stanza — attesa,
la mia memoria ti cercò negli anni
floridi un nome, una sembianza: pure,
dileguerai, e sarà sempre oblio
di noi nel mondo”.
Tu guardavi il giorno
svanito nel crepuscolo, parlavo
della pace infinita che sui fiumi
stende la sera alla campagna)
CESARE PAVESE
L’avventura poetica di Cesare Pavese si circoscrive in un unico progetto strutturale e linguistico che il poeta stesso volle proporre come documento alternativo all’ermetismo, riunendo in “Lavorare stanca” (1943) i suoi versi in forma di poesia-racconto, opera unitaria e massimamente rappresentativa dello sperimentalismo realistico, anche se le ”Poesie del disamore” (1934-1938) e quelle riferibili al periodo 1931-1940 ne prolungano il clima letterario senza, tra l’altro, farne parte.
Né i versi di “Poesie d’amore” 1934-1938, né quelli di “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” 1945-1946, possono essere considerati organicamente attigui a quelli di “Lavorare stanca”, perché riflettono situazioni esistenziali molto forti, che non hanno nulla di paragonabile alla solarità della prima raccolta dove è insistente il desiderio di fuga dalla vita di provincia , con le sue problematiche sociali e politiche nel conflitto generazionale che si viene a determinare nel dopoguerra, tra mondo contadino e mondo industriale. Pavese inaugura una stagione poetica del tutto nuova all’interno di una rappresentazione delle cose e della natura che, pur ricollegandosi alla civiltà contadina, se ne allontana dai suoi miti per indagare su una realtà extrarurale fatta di nuove tensioni e aspirazioni in un quadro sempre più dinamico della società fortemente dilacerata dai desideri e dalla voglia di cambiare.
Il mondo delle fabbriche, le verdi colline delle Langhe, le osterie, i rossi vigneti di S.Stefano Belbo, sono gli “ esterni” più rappresentativi della sua poesia racconto, che con l’interno “esistenziale” forma un unico canto epico intorno alla triste condizione umana. vista come “stanchezza” , ovvero come “tensione drammatica dell’uomo contemporaneo” , definizione quest’ultima che si rileva in una nota del volume “Poesia non poesia- anti poesia del 900 italiano” di Vittoriano Esposito, Bastogi 1992, dove tra l’altro si precisa: “Altra spiegazione, forse un po’ capziosa ma ugualmente interessante, è data dal Fernandez, in una sua altrettanto ponderosa quanto celebrata monografia, là dove scrive: ”Riassumendo le nostre scoperte, giungeremo a questa conclusione, che il personaggio principale di “Lavorare stanca” è la morte. Ma domandiamoci innanzitutto il senso di questo titolo. Per Pavese, allevato da una madre sola, portata a tanto più rigore verso suo figlio quanto l’esiguità del suo bilancio la renda più austera, l’identificazione tra la vita e il lavoro, il lavoro ingrato che affatica, cioè la madre che si affatica al lavoro (vita = madre),non è inevitabile? La morte, confusa con l’immagine del padre scomparso e rimpianto, scintilla nella notte come una stella magica. Non è tanto lavorare che affatica, quanto vivere.
Vivere, quale usura inutile: la sola maniera d’esistere che non sia assurda è attendere la morte” (cfr. L’èchec de Pavese, Editions B. Grasset, Paris, 1967)
La fine dell’avventura di “Lavorare stanca” è dichiarata da Pavese nel secondo dei suoi due scritti posti in appendice al volume “ A proposito di certe poesie non ancora scritte, datato febbraio 1940) E se “Lavorare stanca” nell’edizione 1943 includerà parecchie poesie scritte dopo questa dichiarazione, è un fatto che esse sono molto diverse dalle precedenti. E’ il distacco da quell’ideale di poesia racconto che Pavese perseguiva dal 1930 e che dal 1936 già dava segni di stanchezza. Dopo la dolorosa esperienza di tre anni vissuta al confino di Brancaleone Calabro, e ad una intensa attività narrativa”. Il bisogno di scrivere per Pavese tornerà solo in occasione di episodi della sua vita amorosa; e saranno sempre versi per una donna presente nella raccolta “La terra e la morte (1945) e “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. (E’ quanto si rileva in una nota dal titolo Il distacco dal mondo di “Lavorare stanca” a cura dell’Editore e in appendice al volume: Cesare Pavese- Poesie del disamore, Einaudi, ottobre 1968, pag. 96).
PROPRIETARI
Il mio prete che è nato in campagna, è vissuto vegliando
giorno e notte in città i moribondi e ha riunito in tanti anni
qualche soldo di lasciti per l’ospedale.
Risparmiava soltanto le donne perdute e i bambini
e nel nuovo ospedale — lettucci di ferro imbiancato —
c’è un’intera sezione per donne e bambini perduti.
Ma i morenti che sono scampati, lo vengono ancora a trovare
e gli chiedon consigli di affari. Lo zelo l’ha reso ben magro
tra il sentore dei letti e i discorsi con gente che rantola
e seguire, ogni volta che ha tempo, i suoi morti alla fossa
e pregare per loro, spruzzandoli e benedicendoli.
Una sera di marzo già calda, il mio prete ha sepolto
Una vecchia coperta di piaghe, era stata sua madre.
La donnetta era morta al paese, perché l’ospedale
le faceva paura e voleva morir nel suo letto.
Il mio prete quel giorno portava la stola
dei suoi altri defunti, ma sopra la bara
spruzzò a lungo acqua santa e pregò anche più a lungo.
Nella sera già calda, la terra rimossa odorava
Sulla bara dov’era un marciume; la vecchia era morta
per il sangue cattivo a vedersi sfumare le terre
che – rimasta sola — spettava a lei sola salvare.
Sotto terra, un rosario era avvolto alle mani piagate
che , da vive, con tre o quattro croci su pezzi di carta
s’eran messe in miseria. E il mio prete pregava
che potesse venir perdonata la temerità
della vedova che, mentre il figlio studiava coi preti,
s’era — senza cercar consiglio — presunta da tanto.
L’ospedale ha un giardino che odora di terra,
messo insieme a fatica, per dare ai malati aria buona.
Il mio prete conosce le piante e i cespugli
Anche più dei suoi morti, chè quelli rinnovano,
ma le piante e i cespugli son sempre gli stessi,
Tra quel verde borbotta — a quel modo che fa sulle tombe —
negli istanti che ruba ai malati, e dimentica sempre
di fermarsi davanti alla grotta , che han fatto le suore,
della Natività, in fondo al viale. Si lagna talvolta
che le cure gli han sempre impedito di dare un’occhiata
degli alberi secchi e che mai , da trent’anni,
ha potuto pensare alla requiem eterna.
GIORGIO CAPRONI
A leggere bene tutte le opere di Giorgio Caproni dall’iniziale “Il passaggio di Enea” 1956, a “Il seme del piangere” 1959 , da “Congedo del viaggiatore cerimonioso” 1965, a “Il terzo libro” 1968 , fino a “Il muro della terra” 1975, si rimane alla fine di fronte a tre topografie spirituali che hanno come riferimento: la città natale, il ricordo della madre e il tema assiduo della ricerca di Dio.
Insolita è la struttura poetica che si rifà alla ballata del duecento con vigore linguistico novecentesco particolarmente documentabile nel “Congedo del viaggiatore cerimonioso” e ne “Il muro della terra.”
Per le considerazioni di carattere tematico attinenti a questa antologia, si reputa opportuno indicare alcuni esiti poetici che riguardano il tema del “viaggio” che il poeta intraprende, di volta in volta, nelle pluralità delle cose e degli eventi , anche dolorosi, che lo portano a chiedere, a fare domande, a insistere su alcuni aspetti “oscuri” della vita e dell’esilio di ognuno di noi: tutti “viaggiatori” in procinto di partire o già partiti “ Sono partiti tutti.” / Hanno spento la luce; / chiuso la porta, e tutti / (tutti) se ne sono andati / uno dopo l’altro /…… “ E io, / io allora, qui, / io cosa rimango a fare, / qui dove perfino Dio / se n’è andato di chiesa /”
Quella di Giorgio Caproni è una denuncia amara dell’esistenza che ci conduce alla fine nello stesso luogo dove si è partiti per cercare un senso a questa vita. Il luogo è spesso oscuro e misterioso. I segni sono pochi e tra l’altro anche indecifrabili .
La ricerca di Dio diventa affannosa e inconcludente.
“Caproni non ha fatto altro che “ congedarsi”…. dalla terra e dalla speranza, come se davvero fosse venuto per lui, poeta viaggiatore, il momento di “chiedere l’alt (La citazione è di Giovanni Raboni che ha firmato la prefazione al volume L’ultimo borgo, di Giorgio Caproni-Poesie1932-1978,Rizzoli Editore, Milano1980, pag. 13),. come se fosse uno di troppo , un intruso in un mondo di rovesciamento dei dati delle mappe nautiche il cui Zenit è sempre puntato davanti a un “Muro”, che va comunque scalfito per aprire una breccia che possa alla fine porci nella condizione di rimanere “viaggiatori” in una città di sole. Il risultato è soltanto una avvilente avventura al di qua di tante rese e sconfitte:“ Amici, credo che sia / meglio per me cominciare / a tirar giù la valigia / Anche se non so bene l’ora / d’arrivo e neppure / conosca quali stazioni precedano la mia”.
Il “viaggio”, assai disorientato, non può che portare al fallimento dell’avventura iniziata senza alcun progetto metafisico: “Ho provato anch’io. / E’ stata tutto una guerra d’unghie. Ma ora so. Nessuno / potrà mai perforare / il muro della terra” , pervenendo semplicemente a: “Un semplice dato: / Dio non s’è nascosto. / Dio s’è suicidato” /. In questo suo “congedo” di “viaggiatore cerimonioso”, Caproni riesce , pur nell’assenza di guide sicure e di indicazioni precise per tutti, a picchettare un territorio dell’anima dove aridità e desolazione, amarezza e spaesamento, lasciano alla fine un messaggio di umana partecipazione al dolore degli uomini.
GIOVANNI RABONI
Con “Parti di requiem”, apparse nell’Almanacco dello Specchio, n. 4, a cura di Marco Forti , Mondadori 1975, Giovanni Raboni riesce a creare tutto un mondo di sensazioni e sentimenti, dentro e fuori l’ambiente familiare visitato dalla morte, che mette a soqquadro la “normalità” della vita e la stessa privacy domestica dalla quale emerge un dolore filiale, al limite dell’annichilimento e del grido soffocato.
Protagonista di “Parti di requiem” è la madre del poeta che finisce con l’essere l’unica dialogante prima di interrompere per sempre il discorso quotidiano con il figlio poeta, che percepisce a fondo l’attimo estremo della vita: “Sempre c’è / poco tempo quando dobbiamo fare / i conti con i morti. E così dico / a mia madre di aver pazienza — a lei / che vicina a morire, ancora / vuol sapere com’era la mia cena…/. E’ un discorso di lucido dolore intorno alla eccezionalità di un “evento” percepito in tutta la sua inevitabilità, che dura anche dopo la scomparsa della madre, con gli oggetti da recuperare, da salvaguardare, da portare altrove e per sempre, come in “Trasloco” / Bisognava rincorrerli — gridare / slittando sulla ghiaia / abbattersi sui platani, volare / sui tre gradini di graniglia /…. prima che qualcuno / (la Gondrand, anche allora?) bestemmiando / per troppo noce, / ansando cieco per le scale /, portasse dentro – prima la testata, poi le molle, le sponde / – il letto di mia madre /.Da qui il senso altissimo e fortemente umano di opporsi all’inevitabile distacco: ” Mi chiedo se una bara / può essere così calda, davvero, come è stato / questa notte in un sogno – / dico calda da dentro se per ridere / cerco di sollevarla, se la tolgo / al furgone, alla fossa, / se l’abbraccio, sapendo nel legno che sei viva/.. . Anche nell’ultimo volume di Raboni dal titolo ”Quare tristis”, Mondadori, Milano, 1999, la tematica del dramma della vita e della Storia si configura in un ampio scenario di nebulosa presenza, come una minaccia su tutta l’umanità.
Il registro poetico è costituito da toni bassi che riecheggiano le vibrazioni del pensiero e dell’anima sempre vigili nell’innescare il ricordo doloroso del passato e le incertezze del presente. : ”C’è luce di purgatorio in questo libro. Le cose sono spiate da pupille socchiuse — / come uno che sta sognando e sa / di sognare e nel sogno si ribella /., per la consapevolezza che “la vita è senza varco liberatorio”, “guardata dal punto di vista della morte” come ha scritto Luigi Baldacci a proposito di “Quare tristis”, perché / “ nessuna storia si può scrivere / se non nella cenere” . (La sintesi riportata che fa parte di un più ampio discorso critico su “Quare Tristis”, è di Enzo Siciliano su La Repubblica, giovedì, 18 marzo1999, pag.42.)
TRA FEDE E RAGIONE
Le risposte al problema della dialettica vita-morte hanno costituito da sempre un’ampia campionatura di documenti poetici strettamente correlati ad una visione teistica e atea dell’esistenza.
Rientrano in quest’ambito alcuni poeti dell’area cattolica come Giovanni Testori, che con “Conversazione con la morte”, Rizzoli (1978) grida il suo fervore poetico con un linguaggio dichiaratamente mistico e ossessivo, lo stesso di Davide Maria Turoldo , e che in Mario Luzi ne: “Il giusto della vita ” -Garzanti 1979, si fa sommesso periodare , tra monologhi e dialoghi in una attesa tutta cristiana della vita ’E’ qui , è in queste opere miti / e chiare che trascorre e brucia / quel che non ho e che pure dovrò perdere/ Tempo passato e prossimo si libra…/ Io, come sia, son qui venuto, avanzo / da tempi inconoscibili , ardo, attendo; / senza fine divengo quel che sono , / trovo riposo in questa luce vuota./ Ma ancor più da vicino si seguano i risultati di alcuni poeti come Andrea Zanzotto, che nella raccolta “La beltà” e nel testo “ Sì, ancora la neve” pone inquietanti quesiti filosofici di assoluto silenzio nelle risposte : “Ma è vero? E che sarà di noi? / E tu perché, perché tu? / E perché e che fanno i grandi oggetti / e tutte le cose-cause / e il radiante e il radioso “ , e che ci riportano immediatamente per congiunzione analogica ai primi versi del: “Canto notturno di un pastore errante nell’Asia” di Leopardi : “Che fai , luna in ciel? Dimmi , che fai, / Silenziosa luna?…..”Dimmi…. a che vale / Al pastor la sua vita, / La vostra vita a voi? / dimmi: ove tende / questo vagar mio breve, / il tuo corso immortal?, e ancora alcuni spunti maudit di Dario Bellezza circoscritti in forti sigle d’angoscia e di autodistruzione: “Dio può pensare se stesso essendo / puro spirito. Ma pensando sé / ci annulla vigorosi nel corpo /a cospetto del micidiale sonno / che ci tiene e ci lascia / ma sempre inconcludente / ci depone alla fine dei giorni, / delle ere, e tutto è notte / conchiusa nel vetro stellare / della luce senza speranza ( di vivere oltre i mondi e le età “., per finire, con Pier Paolo Pasolini che , con “Le ceneri di Gramsci” , s’apre ad un colloquio sofferto e solitario davanti alle pietre tombali evocanti il passato dopo l’offesa della morte“ Tra i due mondi, la tregua, in cui non siamo. / Scelte, dedizioni… altro suono non hanno / ormai che questo del giardino gramo / e nobile, in cui caparbio l’inganno / che attutiva la vita resta nella morte. / Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno / che mostrare la superstite sorte / di gente laica le laiche iscrizioni / in queste grigie pietre….”
Sono questi i risultati etico-morali che s’aprono a diverse soluzioni provvisorie o definitive nella complessa ricerca della verità. L’avventura della vita è anche impatto con la morte continua ed eterna. Il Nulla presente e globale investe più da vicino la paura dell’essere – qui e ora – come momento effimero su cui fare i conti.
Permane nella nostra civiltà occidentale la certezza del cupio dissolvi, la condizione contraddittoria tra fede e ragione. Niente è definitivo e tutto è discutibile.
La Natura vive e si rinnova. Ad essa apparteniamo dal principio alla fine.
“Cercare il senso della vita? E’ il modo consolatorio che tutti in certi momenti e passaggi, adottiamo per bisogno di consolazione. Ma trovare quel senso e precluso dalla conformazione stessa della mente è domanda alla quale non c’è risposta. Il senso della vita è la vita, che non ha alternative. La natura si pone forse quella domanda? La natura vive e basta. E noi, non siamo forse natura, a meno di non compiere un atto di luciferino orgoglio che ci vorrebbe far superiori al resto della natura? Noi siamo diversi, ma non superiori. Diversi solo in alcuni aspetti, ma anche noi natura per tutti gli altri” . (E’ un frammento di un articolo di Eugenio Scalfari apparso su La Repubblica di mercoledì 24 gennaio 1995, pag 30, come risposta ad una polemica di tipo esistenziale e teologico con il Vescovo di Como).
A queste considerazioni, tutt’altro peregrine e che rispecchiano il libero pensiero contemporaneo della morte di Dio, si frappone e, per alcuni aspetti sovverte le tesi eretiche dell’Illuminismo kantiano, la presenza millenaria della fede e il mistero della Resurrezione di Cristo.
Alla morte pacifica e serena si contrappone quella , violenta e orrifica, delle guerre e dei genocidi.
Qui non mancano testi esemplari per la loro drammaticità e per le sequenze di dolore e di smarrimento.
L’orrore della guerra e il senso effimero della vita sono ricondotti in un unico momento di pietà da Giuseppe Ungaretti che testimonia , nel giro di pochi versi, una realtà d’esistenza precaria :”Si sta come/ d’autunno / sugli alberi / le foglie ”che è già annuncio di premorte e di attesa dolorosa, la stessa che ha portato Salvatore Quasimodo a dire: “ E come potevamo noi cantare / con il piede straniero sopra il cuore, / fra i morti abbandonati nelle piazze / sull’erba dura di ghiaccio, al lamento / d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero / della madre che andava incontro al figlio / crocifisso sul palo del telegrafo? / Alle fronde dei salici , per voto, / anche le nostre cetre erano appese, / oscillavano lievi al triste vento”, e a rappresentare con Vittorio Sereni la delusione del tempo e della Storia ne il “Diario D’Algeria” e ne “Gli strumenti umani”, due realtà poetiche scandite da un presente che è assenza e graffio autobiografico sull’esistenza, che diventa indagine prospettica del futuro, come in ”Autostrada della Cisa” in “Stella Variabile” , Garzanti Editore , 1981- “Tempo dieci anni, nemmeno / prima che rimuoia in me mio padre / (con malagrazia fu calato giù / e un banco di nebbia ci divise per sempre) /. Oggi a un chilometro dal passo / una capelluta scarmigliata erinni / agita un cencio dal ciglio di un dirupo, / spegne un giorno già spento, e addio /. Sappi — disse ieri lasciandomi qualcuno – / sappilo che non finisce qui, / di momento in momento credici a quell’altra vita ,/ di costa in costa aspettala e verrà / come di là dal valico un ritorno d’estate”.
GIORGIO BARBERI SQUAROTTI
Il discorso sulla salvezza e sulla perdizione trova in Giorgio Barberi Squarotti uno dei più acuti osservatori della realtà contemporanea dove la vita è già predestinata al nulla e in questa percezione trovano ospitalità storie, profezie, ammonimenti, descrizioni di uomini e donne collocati in bolge sulfuree e senza via d’uscita, il tutto magnificamente trasposto in una ampia galleria di personaggi di dantesca memoria, che discutono ”dell’inesistenza del Nulla”, tra finzione e realtà, in un clima di sangue e orrori, di storie e luoghi non facilmente individuabili, eppure straordinariamente (pseudo)reali, collegati da un ininterrotto continuum lirico che ha nel suo interno il ritmo incalzante delle favole.
Solo quando il tema esistenziale si complica metaforicamente allora si fa più complesso il discorso di Squarotti che affida al significante ogni forma di messaggio posto come veicolo di indagine sui grandi temi contemporanei e metastorici.
Ciò che colpisce è la capacità del poeta di riproporsi come soggetto abilitato a trasmettere il codice della realtà secondo le proprie chiavi di lettura, con la presenza di Dio che, secondo un verso di Barberi Squarotti, “c’è capitato in mezzo da sempre”.
In quest’ambito si colloca una delle sue opere : “Notizie dalla vita”, Bastogi Editore, 1977 , a metà strada tra la poesia-racconto e le infiltrazioni sperimentali dell’Avanguardia.
Trattasi di un dossier-poetico sull’agonia di eventi storici e sociali nei quali la spinta emozionale di tipo privato forma un’unica e organica rappresentazione della vita, vista come una via crucis con tante stazioni di dolore.
La fustigazione e lo strazio delle carni sono il risvolto metaforico di un clima politico e sociale concomitante agli esiti storici che caratterizzarono la presenza al potere dei colonnelli in Grecia, “il Cile di Pinochet, la guerra del Vietnam e la nostra stessa esistenza in Italia, fra sussulti , rinnovamento e complotti oscuri e crisi economica”.
Più in specifico si può dire che il volume è la rappresentazione di corpi violati e battuti a sangue, in un passaggio di anime destinate al dissolvimento e avviate verso un luogo “ove è tenebra e stridore di freni e fiamme”..
Certamente in una operazione poetica dove l’occasionalità dei dati a disposizione è spesso molteplice e pseudoreale, la letterarietà assume un ruolo egemone sui sentimenti a tutto vantaggio di un prosaicismo lirico per una grandiosa visione della realtà riportata come Storia e Commedia.
Ma già con le raccolte successive riunite nel volume antologico “Dalla bocca della balena”, Genesi Editrice, 1986, si assiste ad una personale adesione ad un codice linguistico tutt’uno con l’io narrante che si sviluppa attraverso una ”scrittura straordinaria, che dà fondo al massimo delle risorse psicolinguistiche per denunciare l’onnipotenza della “Morte” nel suo globale aspetto del “Nulla”, ma anche della “Vita” come tale, a partire dalla megavita cosmica a finire a quella microbiologica dell’uomo e della sua storia e fino alla cronaca del suo “non essere” spicciolo e quotidiano”. (Giuseppe Zagarrio, da “Febbre, furore e fiele” Mursia 1983, pag. 577).
DA UN TRENO
La ragazza nuda (dal treno, mentre andavo a Milano
per parlare di Gozzano o di altri prodotti di bellezza,
non ricordo), fra i rami giallo-rosei dei salici e
le fogliette pallide, appena esplose dalle piogge
di primavera, non altro che un’immagine, e già più non ricordo
forse bionda o, e rosei i capezzoli, la mano
sopra il pube oppure sotto le pallide mammelle? soltanto
ormai una macchia bianca nella memoria come dentro il verde
del fosso, dopo Vercelli, non altro e presto una
vuota voragine che inghiotte questa giornata di aprile (o
di dolce autunno, ancora tiepido?) come quarantaquattro anni di
quasi vita e troppe parole scritte e dette e altre non
pronunciate quando era il tempo, tutto quello che
non ho fatto o ho visto o non saputo, e
anche questa ragazza che
forse soltanto un luogo letterario o un’occasione per
parole parole parole sulla pagina in realtà sempre bianca dove
dovrebbe essere scritta una storia mal raccontata ma viva
almeno un poco,
e tu allora, così chiara distesa sopra il letto
nel tramonto quieto di Pasqua, dopo la grandine livida nei fossi
dove? o la luce del tuo corpo nudo nella notte di?
o fra l’erba e le canne, quando? Dieci
inverni prima o domani? O solo una confusa fantasia,un pò
morbosa, un sogno di solitario? Ecco: restano poche
parole sopra fogli
quasi illeggibili, il fantasma di un aprile improbabile
di gioia e lacrime (quanto diverso da questo e da ogni altro,
qualche reminiscenza letteraria, ma nulla della vita se mai ci
fu vita, neppure un’ombra, dentro o fuori, di
ciò che è stato o ho creduto di vedere, chi sa dove.
aprile-agosto 1974
*
Tre soli anni, e già più non ricompongo i
tratti del tuo volto che per quarant’anni e più mi ha vegliato,
e allora che posso dire ormai di te, di me, di una vita d’amore e
pena per un’altra di parole e vento e gesti
venuti sempre troppo tardi, all’orlo di
una stanchezza mortale o anche un poco oltre, dove è
lo scherno dell’inutile e del vano, e non c’è più risposta,
da nessuno ?
Se ti riporta il sogno, ma sei tu se ora
il tuo passo è così lieve e rapido, i capelli neri il
volto senza rughe, la voce non interrotta dall’affanno?
Mi dicono che ora sei così, nell’altro spazio
dove nulla si perde, e nella noia dei vizi ripetuti, delle
viltà moltiplicate nello specchio di ogni anima,
nei rancori, nelle ire, nelle quotidiane crudeltà
così uguali per tutti che neppure Dio distingue vittime e
colpevoli, il bene che solo è tuo risplende. Io non
vedo nulla, vecchia anima talpa che così poco scava dentro
a sé, e
preferisce le voci d’altri libri i cataloghi gli archivi;
ma so forse che questi colpi da basso, fitti contro la
porta, e i passi più numerosi nella strada delle
scarpe chiodate, e i lamenti e le grida e i colpi di
frusta e anche questa primavera stenta e le tempeste
che abbattono alberi e uccelli e l’acque torbide,
sono perché il mondo t’ha perduta, e
il giudizio di Giona può ormai compiersi.
(in treno, 18 aprile 1974)
LO SGABELLO DI DIO
ad Angelo Jacomuzzi
Sì, è vero, anche se accumuli a migliaia
fogli su fogli scritti ai margini
(e anche qualche disegno d’angelo, una rondine
in un angolo del cielo bianco), il tremore di una foglia
dove è caduta una riga, forse, un volto
vecchio si affaccia da una macchia bruna,
sembra voler parlare, poi gli occhi come se
per la prima volta avesse visto davvero il libro scritto
del mondo, troppo lungo e confuso, pieno
di storie senza senso e tutte di morti da chi sa
quanto tempo o uno traballa un poco, poi si lascia
cadere troppo lentamente a terra,
allargando le braccia, mentre ancora
in una mano convulsamente stringe
una bandiera vuota); ecco, neppure —
mettendo l’uno su l’altro tutti i sogni
sognati sul Parnaso e altrove si può giungere
anche soltanto a intravedere lo sgabello
dove i suoi piedi a volte posa Dio —
un passo lento, un’orma pesante sul broccato
rosso, la punta di una pantofola un po’ lisa
nel tremare dell’aria come dopo
il primo tuono della primavera
proprio niente di tutto questo, solo un muro
di carta o di cartone, e quale spazio
può rimanere oltre un angolo d’aria muta e morta,
un lembo di tenda grigia che un vento
inesistente a volte spinge fino
ai fogli, una mano di bambino che saluta
in un’alba d’inverno, il punto animato di una mosca
che cerca a lungo la parola fine
dove fermarsi.
Squarotti si serve dei dati minimi della quotidianità per approdare ad una sorta di spartito teatrale dove i personaggi sono presenti con tutte le loro pene e le loro confessioni, che la Storia o il semplice Caso mettono a centro di una Commedia nella quale sempre più incisiva e persistente è la denuncia del Nulla .
Il risultato è quasi sempre una sconcertante ed epica rappresentazione della realtà nella quale si vengono a inserire alcuni rapporti autobiografici come consuntivi di una vita .
A ciò si aggiunga una insistente accentuazione del racconto tra “finzione e dolore”, dove i dati esterni sono sì denunciati con vigore e ironia, ma si propongono anche come visione dell’occhio interno del poeta che non concede nulla al patetico o al mimetismo emozionale.
XXXV
Una lenta vecchiaia, lunghi anni vuoti ormai
di lamenti di ire, di perdute profezie, di
affannose occasioni, e anche della fatica di vivere:
in riva a qualche collina senza venti
o accanto a un antico fiume che non varia
con le stagioni e nulla scorre in esso né
foglie né le ore della luce e dell’ombra né barca più
che l’attraversi carica di anime tenere e nude e un po’
piangenti
al contrario di te, aveva molta paura della morte
o forse troppo amore per i corpi nuovi in ogni primavera
subito
scoperti un poco nella luce ancora cruda senza
verde di foglie, per la ripetizione delle
albe, per l’arrivo dei merli, per le viti
nere sullo sfondo di neve, per i ritorni trepidi di te,
per la fuga della ragazza bionda avanti al dio che ride:
troppo poco ti ebbe, il tempo fu quasi
tutto sprecato senza che se ne accorgesse, scrivendo
parole come chi beve vino per stordirsi di
qualche cosa che neppur più ricorda: ecco, anni
avrebbe voluto per guardarti con i suoi occhi sempre
meno capaci di riconoscere quel che non c’è oppure non esiste
una vecchiaia anche con tutti i mali e uno spazio esiguo,
una finestra, una poltrona, pochi passi pieni di fatica fino al letto .e
anche un lungo tempo per morire in una nebbia
lentissima, ma per riempirsi la memoria di te,
e le carezze e i baci e la tua anima
più chiara della luce di quell’alba di luglio, quando
capì che l’ironia di Dio lo avrebbe inviato molto
lontano da te, in qualche nobile castello d’anime
eloquenti, che discutono dell’inesistenza del nulla.
(Venezia, 5 settembre 1975)
XXXIX
Ecco che cosa ti lascerò: questi cinque altri morti
dopo un’infinità di altre morti che neppure
tutte le foglie di tutti gli autunni di tutti i
tempi da che c’è l’autunno; in fila, di corsa o
legati a qualche albero, bendati o con gli occhi pieni della
luce splendente del mattino o trascinandosi ai piedi
di Creonte
o nudi e già mangiati un poco dalla morte e quale
scriba nella cancelleria di Dio più ne tiene il
conto per l’improbabile resurrezione della polvere:
la Storia, insomma, che anch’io ebbi da mio padre,
ufficiale sul Carso e su chi sa quali altre montagne dell’
inesistenza, questo dominio del nulla dove tutti
(anche tu, dopo di me) abbiamo un posto
inutile.
Porto Sant’Elpidio, 28-29 settembre 1975)
SCRIVERE NON VIVERE
Non riuscì a fare molto più che scrivere,
eppure sapeva che ben altro bisognava
perché meno dolore fosse al mondo
e un poco più di pace , per te, dopo le fatiche della sera.
Non capì mai se quello era davvero l’ordine di Dio
in cui credette troppo poco per
non avere dubbi sopra la giustizia delle piogge
d’autunno sull’auto rovesciata per la strada
di Narzole, con dentro gli occhi ancora aperti
di non si sa se bambini oppure vecchi,
o per non scendere al Campo dei Miracoli
a porre i quattro talenti (ma se ne dimenticò,
poi, e non ritornò mai a vedere se la Volpe
li avesse dissotterrati, oppure il Cane
fedele, che è amico dell’uomo, come è noto).
A metà della pagina si alzò
per baciarti, uscì nella nebbia smorta della
sua città d’anime zoppicanti, quasi mute
per il male alla testa, non capaci
più neppure di un saluto, in qualche luogo
illuminato bene pronunciò
le solite parole, e nulla fu mutato nulla
nel mutare della storia, nel tuo sonno
agitato, nel respiro un poco affannato dei
bambini, come per un brutto sogno.
(Roma. 7 maggio 1977)
I LIBRI
Dicevano di lui che troppi libri
e poi ancora i sogni di altri libri
e tutta una biblioteca di Babele
versi smisurati storie di minimo
poeta di qualche osteria di Cesenatico
o scriba nel comune di Monforte,
fantasmi appena citati negli archivi
di Apollo, righe, righe di parole
poco comprensibili, descrizioni del nulla, il
nulla che l’acqua limpida del fiume
porta insieme con le foglie le nuvole
le barbe delle capre il volto stupefatto
della ragazza nuda, sorpresa mentre contempla
nel tremolio delle acque il tremito del corpo
troppo ancora bianco nel primo sole d’aprile;
il nulla che viene a galla nello specchio
in un giorno di pioggia, mentre attendo
il tuo ritorno a casa, e non rivela
nessun futuro, non illumina nessun passato che
non ci attende, in nessun luogo; ecco:
ma pensate a ciò che non ho scritto,
eppure i tempi gli chiedevano, inni
ai marinai di Odessa, carrozzine
di vecchi giù da strade in discesa da
colline, bandiere secondo le ore del giorno e gli umori
dei troppi capi nelle piazze, la
Verità nuda per i fotografi sul palco
del comizio, sorridente, girandosi
con lentezza perché tutti le vedessero
bene le lunghe cosce, il pube biondo,
i trionfi di carta e legno trasportati
per le strade sui camion rossi, le sentenze
dei vescovi, elenchi di puttane, il prezzo
degli operai beatificati su tutti gli altari,
discorsi in versi sopra i versi mai
scritti da nessuno, il suo cuore un po’ pavido,
le vicende di un’infanzia in campagna,
con troppi compagni morti giovani per non
piangere dolcemente sui ricordi, e tutto il resto che
la Morte invano in quegli anni contendeva alla
Moda: lodatemi per quel che non ho scritto e avrei potuto
scrivere, chiese alla fine, citando
a memoria, e bruciò la sua vita in mille
falò nel prato di Monforte, non i libri, non
i libri nei quali è noto che non c’è nulla se non morti
e qualche verità non molto utile.
(Marina di Carrara, 29 giugno 1977)
XLIII
Visse in una città, per lo più poco accorgendosi di vivere
(un margine di pagina, non più, gli bastò per quasi
quarant’anni,
cercando un posto ma fatica fra
Baltusaraj e Baudelaire nei dizionari, poi tu
gli desti un po’ di disperazione e un po’ d’errore, e
s’accorse delle foglie rosse d’autunno, delle mura
macchiate della stanza, di te a poco a poco nuda nella
lunga spiaggia di primavera, nella stenta luce del
crepuscolo, del
resto non si hanno notizie (ebbe figli? Visitò
l’Averno? vide Dio o, miope com’era, per Lui scambiò
Giordano
Bruno o un ignoto poeta dei seicento? Conobbe erbe
boschi le
orme della volpe? o si smarrì fra le case le nebbie le
rapine
alle banche le povere anime ignude le foglie lievi di
Sibilla?, è
certo che non scrisse libri, forse qualche poesia per nozze o per
monacazioni, non altro risulta a questo archivio.
(Padova, 18 maggio 1974)
*
Sotto una quercia o fosse anche soltanto
un tiglio o un gelso, ma che c’è mai di male
se vedeva in quell’ombra esigua voli d’angeli
che venivano a porgergli bicchieri
colmi di latte e miele e mormorii
di parole quasi già ordinate in versi,
o la luce di colpo vi si apriva
di un giovane corpo nudo, sorridendo
la ragazza restava a lungo lì,
a farsi guardare, fra rapidi rossori,
non chiedendo nulla più di uno sguardo sereno,
ed era forse più grave se era un cane
con grandi macchie brune sul mantello
candido, si sedeva ai margini del foglio,
come in un’attesa festosa che poteva
durare anche tutta una giornata e forse più ancora,
perché una gioia deve pure giungere
da oltre il muro che circonda il giardino
quieto, e se davvero ha visto il volo rumoroso delle gru,
davvero l’acqua scura della fonte
della vecchiaia che dà finalmente la saggezza,
o il volto di Dio in tutta la sua terribile potenza:
si dice che abbiano parlato insieme a lungo (no,
non da solo, non al vuoto del vento,
non alle ombre delle nuvole che passano
sullo specchio lucido del prato
e vi lasciano macchie un po’ sfrangiate,
come tracce di perdute anime a cui non disse nulla
quando era tempo), e dopo, allora, come
non rimanere lì, ad attendere se mai
volesse ritornare, o almeno un segno
di lui, se s’alza ancora la brezza della sera,
se il tramonto si riflette rosso su una foglia
tenera (e non c’è altro segno, non altro, ormai,
cancellato com’è quello di Giona),
se una colomba becca nella terra
bruna, se giunge il richiamo di un ragazzo
dalla strada, risponde forse un sussurro,
forse solo il brivido della vita che sfugge,
al di là di tutti i muri del paese di pianura,
nel sogno della folla irosa di domenica
che passa calpestando rose alberi
cespugli dove vecchi stavano nascosti
a guardare se passassero ragazze
abbracciate a caproni neri con occhi di fuoco:
ombre di vivi che si tenevano per mano
nel cieco giorno, e anche Dio che c’è capitato in mezzo
da sempre, resta in ginocchio, appoggiandosi a terra con
il braccio,
muove le labbra come per un richiamo o almeno
per una battuta finale: e credete
che sotto l’ombra di un faggio o di una quercia
nel chiuso del giardino non si possa
udire anche ciò che è quasi muto ormai?
Ecco: piega un poco il capo, anch’egli
muove le labbra e anche la mano come
per un saluto estremo, fissa le
stelle che risplendono nel cielo
pur nella luce altissima del giorno,
i re che passano in corteo, con le corone
d’oro sulle fronti sporgenti, ossute,
mutando luoghi dalle grotte del cielo,
dal trono al buio di capanne e canne
e la doppia schiera dalle due parti del sole,
infine tutto così chiaro per una volta, tutto così logico
e concluso per sempre nel delirio.
(Roma, 30 marzo 1984)
SULLA STRADA DI TRAMARIGLIO
Infine, sulla strada di Tramariglio, incontrò
il suo serpente, esiguo, stento, grigio-verde come
un misero soldato d’altri tempi,
e neppure sapeva parlare molto bene,
col suo accento un poco dialettale e una leggera
balbuzie: gli indicò appena le ragazze
che correvano nell’aria umida di pioggia
quasi nude, il libro che tirò fuori dalla borsa
di finta pelle, lo sfogliò distratta-
mente, si fermò su una pagina, lo chiuse
con un sospiro senza dirgli di leggere,
rassegnato estrasse la Morte, il Re di quadri, la
regina di Saba, il Sole, la Città inventata,
lo Scettro, l’Annegata, il Pinnacolo del Tempio
da cui tutti i deserti della Terra
e d’altri luoghi ancora e i monti magri e
le vuote cavità del Nulla (e anche due
o tre fotografie, consumate, un po’ sfuocate, di serene
foreste, di acque tranquille, di ruscelli
fra lisce pietre candide di giovani donne con abiti celesti
e pizzi intorno al lungo collo bianco
e gli ombrelloni a righe e saluti quasi
invisibili su labbra che si sfanno:
con un sorriso invitante, ripassandole
davanti ai suoi occhi, poi tristemente riponendole)
due o tre versi bellissimi, poi un lungo silenzio:
-Venga a prendere il tè (indicando il
nero antro la strada,, e dentro , a tratti,
qualche breve bagliore e qualche voce),
ma forse è tardi, forse (guardando il suolo arido)
prima di notte pioverà, ma le posso offrire anche la pace,
questa pace dell’anima nell’ora
in cui nulla accade in nessun luogo e
nessuna notizia giungerà al suo riposo se si siede
sulla candida pietra presso l’albero
di noce, neppure un alito di vento o
una foglia che cade o la fila di formiche che
interrompa un passo o il franare di un mucchio
minuscolo di terra: adesso devo andare
(toccando timido l’orlo del cappello
stinto), un po’ soffiava , era molto pallido,
gli sorrise in risposta , lo aiutò
a strisciare fra i lentischi e i sassi
aguzzi dove meno ripido ed erto era il pendio,
verso il cielo smorto del tramonto.
GIOVANNI RAMELLA BAGNERI
A spingere la tensione mentale e psicoemotiva oltre i confini dominati dal negativo, è Giovanni Ramella Bagneri che, in uno dei suoi volumi più significativi dal titolo “Il teatrino del mondo”, Forum 1984, mette in evidenza un mondo collassato e privo di luce , con visioni sulfuree e infernali di prospettiva postnucleare dove la morte occupa davvero un primo piano, per rivendicare un ruolo primario sulla vita, attraverso alcuni aspetti orrifici e opprimenti, che richiamano alla mente certe atmosfere del romanticismo inglese caratterizzate dal senso del macabro e della ineluttabilità corrosiva delle cose. Quelli di Ramella Bagneri sono attacchi a fondo portati su tutto il fronte dell’esistente. Tutto e vuoto e niente si salva davanti agli occhi del poeta. La morte è già nel nascere di ogni cosa. Niente resiste e tutto brucia o si dissolve perché questo è il luogo dove “nessuno è veramente” .
Per Ramella Bagneri non c’è neppure la speranza di un giudizio finale e collettivo. Non vi sono interlocutori, né messaggi da far pervenire per una proposta di salvezza. Siamo davvero davanti al negativo universalizzato dalla morte e al trionfo della concezione meccanicistica della vita., che coinvolge tutti, senza alcuna possibilità di fuga, nonostante le piccole felicità, e le brevi illusioni alle quali far ricorso per esorcizzare “ il luogo della paura deforme” dove qualcosa pure si scorge, ma sono soltanto / impronte, scritte oscure, arcane / segni non segni, forse labirinti”; tracce di ciò che già è stato e che non ha nessuna possibilità di rigenerarsi.
“Il suo è un mondo rigorosamente oggettivo. La fantasia opera a partire da un giudizio di annientamento della presenza dell’uomo sulla terra (come Soggetto), e delle possibilità future di ricostituzione. L’accedere storico è finito nel cul-de-sac di una palude dove pullulano solo germi mortiferi. Un poeta che, tra gli anni cinquanta e sessanta, piuttosto che dialogare col suo tempo (tutto proiettato nell’ansia dello sviluppo) si elegge a compagni di viaggio i poeti del tempo della fine (nonostante la pluralità delle ascendenze, non necessariamente limitate alla cultura mitteleuropea) si connette con questo nostro tempo di restaurazione e di crisi (di ristagno o blocco dello sviluppo) che ha restituito un potere inquietante a Hòlderlin e a Tralkl, a Baudelaire e a Eliot ,a Rilke e a Kafka, neutralizzati dallo strutturalismo a meri sistemi di segni linguistici.” . (Nota di Tiziano Salarei in quarta di copertina del volumeIl teatrino del mondo, di Giovanni Ramella Bagneri, Forum, QG, Forlì, aprile1984).
CORO
Niente può essere completo,
manca sempre qualcosa,
ma ecco la nave laggiù
e la vacanza è finita.
Prendiamo su i nostri quattro straccetti,
arrotoliamo i nostri sacchi a pelo,
è stata proprio una bella esperienza,
abbiamo visto quello che c’era da vedere:
non abbiamo visto quasi niente,
ma diventerà bello un po’ per volta,
quando saremo vecchi
ci sembrerà una favola.
Ecco la nave laggiù,
dondola dolce nell’acqua inquinata.
A bordo a bordo a bordo a bordo.
Non posso più lasciare questo luogo.
-Vieni via, vieni via:
non è posto da restarci a lungo.
Sei sceso nel profondo,
hai avuto la tua illuminazione:
che cosa cerchi ancora? Non c’è altro.
Altrove tornerai quello di prima.
Ma ecco sei già docile e quieto
e il viaggio fino a casa sarà dolce.
Quando saremo laggiù
ripenseremo a tutto questo.
Non ne caveremo forse niente
o forse , chi lo sa, qualcosa
che ci aiuti a tirare avanti un poco.
Non pretenderemo di capire.
Un sogno, forse, un ricordo, è già molto.
Noi, non siamo di più.
VOLPE E GATTO
Cercando le ossa, i due, incontrati
dove l’albero serpeggiante ha brevi,
piccoli bagliori crepitanti:
volpe e gatta, goffe curve maschere
con bastoni da cieco e mantellucci
di tela di sacco, ragnata:
tendono il piattino, lo ritraggono,
ripetono una loro cantilena
che dice: “Non si parla più di te,
non si parla più di nessuno, qui:
ormai parlare è assurdo, qui si perde
consistenza, si perde tutto, qui:
anche tu sei già nebbia,
ti guardiamo attraverso”:
vengono avanti, zampine rattratte:
ma falsi ancora una volta,
pronti a scattare, unghioni duri, aguzzi,
manico di coltello da una tasca;
respinti frignano un poco;
“Non mi lascia cavare gli occhi, lui,
non si lascia striare:
ma crede di essere vivo,
crede di esserci ancora”;
se ne vanno, si voltano ogni tanto,
scendono per la china
fin dove sprizzano piccoli fuochi
azzurrini di rocce;
nebbia dissolta, cielo
che fiorisce di stelle:
vorticano scintille nel vento
gelide stelle bianche palpitanti,
compongono figure geometriche;
ora come una frana,
cielo vuoto, di nuovo
gremito, un luccichio che brucia,
le voci dal basso : “Tu, ci sei?
No, qui nessuno è veramente”.
DOPPIO CANTO D’AMORE
(A)
Se mi amerai, e questo è più facile in primavera,
uscirò sotto la pioggia a cercarti una corona
di ortiche e penne di corvo e un manto di carta di giornali
e, preso l’anello regalo trovato nel detersivo,
ti condurrò a un altare ornato di corna di becco.
Se invece non mi amerai, e questo è più facile d’autunno,
con una borsa di tue fotografie proibite
andrò a propagandarti per i quattro punti del mondo
finchè tutte le camere le cucine delle casalinghe
non siano piene di strilli e di pantofole scagliate.
(B)
Se mi amerai, e questo è più facile in primavera,
mi alzerò dalla panca all’angolo del camino,
mi toglierò il grembiule cenerentolo,
mi laverò la faccia e mi riavvierò i capelli
e farò passi di danza fino a te.
Se invece non mi amerai, e questo è più facile d’autunno,
tornerò al mio cantuccio e spingerò via il camino,
mi leverò il vestito da ballo e le scarpette di cristallo,
m’infilerò i blue-jeans e accenderò il televisore
e aspetterò che venga qualcuno più bello di te.
(A)
Se ti amerò, da mattina a sera sarò in giro
a cercare fuscelli per il nido,
ti coverò le uova perché tu prenda respiro,
insegnerò ai pulcini a far pio pio
e sarò tutto fiero e soddisfatto di me.
Se invece non ti amerò, butterò all’aria il tuo nido,
non ci saranno più uova e tanto meno pulcini,
ti beccherò e ti caccerò via,
poi sul ramo più alto starò io
a fare in modo che non torni più.
(B)
Se ti amerò, ti darò da mangiare
sempre la stessa minestra, ma con una tal grazia
che non sentirai più bisogno d’altro,
e se alla fine sarai grasso e sazio,
sarò tranquilla e sicura di te.
Se invece non ti amerò, quella minestra
diventerà un’acquaccia mal salata,
buttata lì senza un minimo di grazia,
sbrigarsi perché poi c’è da fare altro,
e se non sei contento prenditela con te.
(A)
Da gennaio a dicembre ti amerò per il sì
e ritornando indietro ti amerò per il no.
Ti amerò con la pioggia e con la neve ,
col caldo e il freddo e il bello e il brutto tempo.
Amerò in te ciò che passa il convento,
quello che prendi perché non c’è altro,
ma non lo dirò mai, nemmeno a te o a me.
Amerò in te gatta e capra e gallina,
quella che morde e quella che ti becca,
quella che graffia e quella che t’incorna.
Amerò in te la notte e il giorno,
ma così rassegnati tutti e due
che non mi accorgerò nemmeno della morte
quando verrò a riprendersi la museruola e la catena.
(B)
Dal lunedì alla domenica ti amerò per il diritto
e ritornando indietro ti amerò per il rovescio.
In ogni settimana mese stagione anno ti amerò.
Amerò in te ogni mia sconfitta, ogni vergogna,
il brutto della vita, il disgustoso,
ciò che si vorrebbe dimenticare,
ma non lo dirò mai, nemmeno a te o a me.
Amerò in te il caprone, l’asino, il topo e il pidocchio,
il viscido, lo sporco, ciò che ti salta addosso
e mai riesci a scrollare da te.
La paura, il sonno della ragione.
Ciò che ti rode, ti strania e ti svuota.
Alla fine sarò così contenta di morire
che quasi non sentirò cadere a terra la catena.
DON GIOVANNI
L’aria greve, rossastra ,aveva lampi
e nembi si addensavano su quella
fine di settimana. Risalivano
soffi caldi la valle accesa e rombi
attutiti, da un indistinto inferno,
si protendevano. Sopra
poi piombava la notte.
Si riscosse ed accese
a sigaretta. Poi fissò una luce
angolata, in un brivido, e gli chiese
l’ora. Il tempo moriva: sprofondava
torpido (-siamo vivi
come morti-) nel luogo: case
di cartone, palazzi
altissimi, campagne,
il riarso vallone del giudizio
e penitenti in bianchi paesaggi
invernali rigati di acque gelide,
immagini di copula e parto,
travolte, ora pianure e treni fino
alla sala da ballo, corpi come
torce accese, qualcosa che bruciava,
si contorceva, un atto di possesso
e ritmici tamburi, come cuori,
nella nebbia, brandelli di giornali,
in una piazza un comizio; nel luogo
sdoppiato, lei nervosa,
luce radente sugli occhi, parole
rapide, lui con la catena al collo,
quieto, forse felice, nell’ombra
calda, automobili ferme, qualcosa
da acquistare, possedere e squilli
di cornetta, feroci,
da sala da ballo,
giardino di delizie, vuoto dietro,
il Demonio e la Morte
in una superficie liscia, fredda;
invecchiare con faccia senza rughe;
corpi elastici, eretti
una maschera in faccia,
catena al collo: il tempo
divampava, ardeva lingueggiando,
contorcendosi: e ancora
quel torpore infinito,
giù nel pozzo delle delizie, immersi
in un vento in un suono sempre uguale,
la stessa nota tenuta, dolcissima,
acqua mossa, ninfee sull’acqua trepida,
larghe foglie sull’acqua,
gesti grevi: e la stella
cadente, l’ora affondata nell’ombra
calda, il materno battito di cuore
nella notte estenuata, lunga,
popolata da sogni, regredendo,
nebbia e nebbia, gente per una strada,
fuoco dall’alto, la notte materna,
la punizione, oh la punizione,
catena al collo, sognando,
maschere nel luogo vuoto dietro.
– Questo è tutto: il futuro è incerto ed io
non posso vivere così. Una qualche sicurezza
e sempre meglio di niente. Ti seguirò in capo al mondo,
ma una casa è una casa
e un anello al dito è pur qualcosa.
II
(Nella casa)
Questa è la nostra casa,
la bella ,solida casa
dove potrai vivere tranquilla.
La bella casa sicura
con le finestre aperte sulla strada
per guardar fuori la gente che passa
per guardare il traffico fluire
guardarti la civiltà
far passare il tempo in qualche modo,
o accendere il televisore.
Seguire il tuo programma preferito,
con le spalle protette,
al calduccio d’inverno.
Qui c’è il televisore
e anche il frigorifero,
c’è la cucina elettrica
e la lucidatrice e il frullatore
e il giradischi con gli ultimi successi.
Ti ho comprato tutto, proprio tutto.
Potrai vivere bene,
almeno fin che dura.
Fin che dura? Come fin che dura?
E’ così. Ti sbatteranno fuori
e non protesterai nemmeno.
– Tu dici fuori di qui?
Chi mi sbatterà fuori?
Tutto quello che c’è dentro.
Tu credi che una casa
sia fatta solo per te.
Una casa è una casa
e tu sei solo una donna.
Se non obbedirai,
ti sbatterà sulla strada
Non mi sbatterà sulla strada.
Dovrai lasciarla sfogare
E poi chiedere scusa.
Una casa è una casa
e noi siamo di troppo.
Da queste parti è difficile vivere.
Occorre rassegnarsi, amore,
perché ne abbiamo bisogno.
Forse, una volta o l’altra
ci brucerà il paglione
e allora sarà finita.
Perché? Finita?
Perché non siamo niente.
Poi verrà qualcun altro e sarà uguale.
Non siamo proprio niente.
Gente che va e che viene
e che non può mettere radici.
Una casa sente queste cose
e allora ti brucia il paglione.
Non voglio andarmene di qui.
Ho lottato tutta la vita
e non mi lascerò cacciare.
Dovremo fare qualcosa.
La lasceremo sfogare,
poi torneremo con la faccia allegra.
come se non fosse stato nulla.
Non possiamo vivere così.
Questo non durerà a lungo.
Occorre essere forti,
dire quello che pensiamo
Tu credi che una donna
non sappia ciò che vuole.
Volevo un anello e ce l’ho.
Volevo una casa e ho anche questa.
Saprò farmi obbedire in un minuto.
Lascia alla donna il suo posto
è fatta per queste cose.
– Ti brucerà il paglione.
Non me lo brucerà.
La prenderai di punta
e ti farà filare.
Una casa è una casa:
chi non si adatta va fuori.
Poi fai la barba e rientri,
ma trovi tutto cambiato
e nemmeno più di tuo gusto.
D’altronde non sarai la prima.
Qui succede sovente.
– Che succede? Che succede?
– Quando ti sbattono fuori,
puoi rientrare dalla parte sbagliata.
– Io non mi sbaglierò.
– Ci farai l’abitudine.
Tu credi di essere davanti
e invece ti ritrovi dietro.
Aspetti di vedere il traffico
e invece non passa nessuno.
C’è solo un vallone di cespugli.
– Un vallone di cespugli?
– O forse è la parte giusta.
Quando rientri, non c’è niente.
Allora accendi il fuoco
e metti i panni ad asciugare
Tireremo avanti in qualche modo.
Coltiveremo la terra,
alleveremo bambini,
almeno fin che dura.
Quando sbaglierai entrata
non ci farai più caso.
Ogni tanto di qua,
ogni tanto di là:
in fondo non c’è differenza.
– Non coltiverò la terra
e nemmeno laverò i panni.
– Coltiveremo la terra
alleveremo bambini.
Quando siamo di qui
è già molto se si mangia.
Ci guadagneremo il pane
col sudore della fronte.
Andremo a dormire presto.
Ascolterai la notte
dilavata. Andrai fuori
se lo vorrai. Non sei la prima che
vi resista.
– Resistere?
– Resistere. Questo è
il luogo della paura deforme
che strepita e impedisce di pensare.
Qui si vive in attesa,
qui si stenta e si spera
di andare via, qui sale il freddo e c’è
chi urla a lungo e ha sempre fame e sete
e di notte si leva dal suo angolo
e ringhia e raspa sulla porta se
nessuno scende: questa è la mia parte
d’eredità e la tengo preziosa.
– Chi è? Chi è?
– Qualcuno , e tutto. Sono due, e tutto.
La Morte e il Diavolo.
Vivono qui da tempo. Sono amici.
– Io non li voglio per amici. Dove sono?
– Nella stalla.
– Nella stalla?
– Ruminano in pace
e mi dànno da vivere e ne ho cura.
– Io non ne avrò cura. Tu, ci penserai.
Anzi, no. Dovrai mandarli via.
Voglio dormire tranquilla.
– Tu non dormirai.
Io non dormirò.
– Perché? Perché?
– E’ così: non dormirai.
Io nemmeno.
Noi non dormiremo né qui né fuori,
potremo al più ripararci dal freddo,
perché quando la Morte ha fame
e il Diavolo ha sete,
perché quando hanno fame e sete
e la Morte urla
e il Diavolo risponde,
e il Diavolo urla
e la Morte risponde,
fanno un frastuono per la casa
e raspano sui muri e sulla porta
e cercano la botola per salire
nella stanzaccia dove stiamo col
lume acceso e rabbrividiamo stretti,
e gridare non val nulla perché
quando vogliono balzan fuori e corrono
per la terra e nessuno può fermarli:
poi tornano quieti
e se siamo fuggiti
ci vengono a cercare.
MA DOVE SONO
LE OSSA DELLO SCRICCIOLO?
Nel luogo oscuro, basso,
la domanda, in affanno,
sempre la stessa, insistente.
“Dove sono le ossa dello scricciolo?”.
Poi le tre piccole piume
portate fino a me
da un breve soffio rischiarante.
Cercare ancora, ancora, ancora.
Non ci saranno ossa qui,
non ci sono mai state.
Ma dove sono le ossa dello scricciolo?
Il percorso segnato
che rade gocce di sangue
fino al cespuglio spinoso,
fino alla pietra piatta, a niente..
“Dove sono le ossa?” Sono qui.
Cerca bene, cercale a lungo, a fondo.
Ti diremo acqua, fuochino fuoco.
“Ma cerca bene, cerca bene,
perché se non le trovi
anche tu sei in bilico
Terza parte
I LUOGHI DELLA MEMORIA
La questione dell’assenza rimane il tema di fondo di molti documenti poetici tra l’elegiaco e il poemetto colloquiale sulla spinta di un umanesimo esistenzialistico e di un imperante illuminismo.
La testimonianza della vita passata è, se non l’unico, certamente il più importante tra i messaggi privati come dimensione del qui e ora , del dopo e oltre.
L’accesso a un mondo imperscrutabile è soltanto ipotetico, a volte di tipo messianico o medianico e le risposte non sempre riescono a dare significative aperture al quesito esistenziale, tanto è vero che le dichiarazioni del vissuto e il senso dello smarrimento convergono nell’unica direzione possibile : quella della “religiosità” della morte vista come evento eccezionale che viene a rimettere tutto in gioco e ad affermare il suo dominio sul mondo.
L’universo metalinguistico, psichico, teistico, filosofico e quant’altro esistente e circoscrivibile nella sfera dell’illuminismo contemporaneo si confrontano opponendosi l’uno all’altro dando alla fine alcune indicazioni che suggeriscono verità riconducibili a scienza e fede.
La consapevolezza del limite temporale di questa vita richiama tutta una vasta letteratura intorno al tema della morte dove la pietas assume un ruolo egemone e unifica dolore e sentimento, filtrando dal passato eventi e storie che restano alla fine gli unici aspetti peculiari di un momento inevitabile ed eccezional,e che richiama attorno a sé fatti e situazioni di calda commozione attraverso un parlare sommesso, trepido, fortemente emozionale.
In quest’ambito rientrano gli esiti poetici di Francesco De Palma che dà l’esatta misura di una dimensione temporale della vita dove la ferita del dolore si apre a squarci di calda rivisitazione e commento del passato come nei testi “19 Aprile 1972” e” Croce di Campagna”:
19 Aprile 1972
“Sono stanco “ dicevi. Una stanchezza
infinita, segnata dentro l’orbite
degli occhi, ancora vivi nel tuo volto
già distrutto dal male. “Sono stanco”.
“Sai, certe volte, alla finestra….” Al mio
trasalimento soggiungesti in fretta:
“Non tenere, resisto”. La tua mano
ormai tutt’ossa stringeva la mano
che cercava d’infondere al tuo sangue
di fratello minore condannato
il mio vigore anziano ancora valido.
Ma riuscivo soltanto ad intonare
al tuo strazio di carne questo strazio
d’anima torta fino alle radici.
Ora nel volto immobile — retratte
le labbra sopra i denti, il mento aguzzo —
la stanchezza infinita si fa pace.
Dinanzi a te scontate, ormai, pagate
fino all’ultimo spicciolo le vuote
speranze della terra e questa assurda
legge di vita che condanna al mondo
comprendo finalmente, dal profondo
dell’esistenza, il senso della morte.
Della tua morte. Tu, lontano ormai,
libero, e santo di dolore, provi
di me, rimasto indietro in quest’inferno,
pietà gentile, tenera.
E questa terra è ancora il mio calvario.
CROCE DI CAMPAGNA
Ecco, la croce è questa.
Piantata or è molti anni sul tratturo deserto
apre le braccia che l’inverno scrosta.
Quante nevi corrosero la pietra che la regge,
quanti uccelli beccarono al suo piede.
Tu, croce derelitta,
m’insegnasti una legge
che non muta, una fede
che non muore, confitta
nel vivo strazio del mio cuore
Passano i tempi e le bufere,
passò colui che ti piantò: fra breve
(quando non so: che importa?)
anche il mio cuore.
Il gelo di questa sera scrolla i rami scheletriti,
l’erba è fradicia di pioggia sulle fosse,
lontano dalle memorie, lontano dai vivi
i morti si disfano sotto le foglie rosse.
Anche Helle Busacca collocandosi su questa medesima lunghezza d’onda riesce a fissare con notevole intensità il senso della solitudine e dello smarrimento come momenti di “resoconto” esistenziale nel quale passato e presente si fondono, mirabilmente, dando la percezione di qualcosa che è stato e che ora non è più:
TV
(revival anni 40)
Come se n’è andata la nostra vita,
aldo, perduta, sprecata,
eppure sempre meravigliosa
anni “40, “40),
quando era giovane nostro padre
quando eravamo ragazzi noi,
e siamo già nell’ottantacinque,
io qui nel risucchio, tu chi sa dove.
Più sostenuto e sommessamente dialogico è il discorso poetico di Margherita Guidacci che realizza con la sua dialettica autobiografica un intenso canovaccio spirituale dove pessimismo e senso misterioso delle cose (già analizzati in una sua raccolta dal titolo “Il vuoto e le orme”), rimangono gli unici elementi di analisi e di giustificazione di una esperienza lirica al limite della delusione-angoscia.
COME SONO ARRENDEVOLI I MORTI
Come sono arrendevoli i morti.
Da un solo tenero gesto, perduto
nel deserto,
ci lasciano creare un amoroso giardino.
Docili indossano ogni veste
di cui li mascheri un’astuta memoria,
sorridono ubbidienti
inchinandosi lievi alle nostre illusioni,
accettano la parte che attribuiamo loro
per una reinvenzione del passato,
ed a tutto consentono e mai non si ribellano:
indescrivibile la loro calma!
O forse è solo una gran compassione
per noi e le nostre bugie dolorose.
Anche per loro nessun disamore
può reggere alla prova della morte.
A cogliere il vissuto come momento circoscritto al limite temporale di tutto il genere umano con riferimenti anche metafisici che travalicano l’inquietante aspetto della realtà, è la poesia di Ferruccio Mazzariol, che, con “ lievitazioni drammatiche sulla meditazione del destino ultimo dell’uomo, riesce a conservare il delizioso candore delle immagini che germinano come una moderna “laus creaturarum”
I
Su queste mappe,
segnate da acerrimi sentieri montanari,
correrà la morte
sino al paese trentino di Sagron-Mis.
Correrà, lampeggiando,
senza stuolo di consorelle.
Correrà da sola il palio.
Insieme la vedremo,
di quando in quando
portare alla bocca un pugno di lamponi blu,
e masticarli lentamente.
II
Le mappe sono magnifiche,
senza i nostri fortini a ostruire
la corsa.
Neanche una buca
inceppa la dirittura finale
della mulattiera.
I ponti ad arco sono scorrevoli.
La morte correrà
con occhi grossi di lanterna
l’ultimo tratto, spargendo
dal suo cesto mirtilli neri
e acqua benedetta.
ANGELO FERRANTE
Più di un medaglione esistenziale sono le ”raffigurazioni” sul caro estinto di Angelo Ferrante che, recuperando i frammenti della memoria, tratteggia nel suo “Album”, eventi, gestualità e colori di un interno domestico nel quale la storia si accentra sulla figura paterna esaltando valori e sentimenti difficilmente attaccabili dal tempo:
da: ”FRAMMENTO”
Questa pausa nella vecchia casa paterna il rubinetto
non funziona come al solito non credo che gli
possa
attribuire tutto l’umido che impregna le mura.
E non odo presenze di lui se non del suo odore
di tabacco quando mi guardava correre
nella strada gli si inumidivano gli occhi.
Da ”ALBUM”
I
i riflessi del sole nel bicchiere di vino
un incendio di pampani contro l’arco romano
le statue decapitate ancora un soffio nelle
labbra di pietra
tu incantato gli occhi rossi la voce accesa dai ricordi
il racconto al vecchio contadino erede di Tiberio e Druso
la mano tagliuzzata le dita gonfie e l’unghie nere di terra
nella pace del tardo pomeriggio d’ottobre
io ti ascolto ascolto la tua poesia le favole di un tempo
sorridendo in volo sui latrati dei cani giro sereno
il volto e gli occhi alle colonne
II
Il tuo volto di cera come unto di sudore freddo
l’infrenabile pianto agosto è afoso e un lampo
è stata la mia corsa quasi alla stessa ora
una sera d’autunno aspettavi il ritorno il mio
la tua coppola zuppa di pioggia ineludibile
ed io che non capivo
III
mai il senso preciso la misura esatta
del perché di tutto nel tuo sguardo
il gesto della tua mano da lontano
quando mi vedevi stroncato dalla pena
non abbozzavi un grido ti appoggiavi al bastone
disegnavi la bocca alle campane e la voce
IV
sulla finestra la facciata ridipinta per tuo
esclusivo volere tu aspetti affacciato alla finestra
il mio arrivo ti spinge a ritirarti vuoi prepararmi
un’accoglienza diversa così all’incontro
mi abbracci come se non mi vedessi da un secolo
e piangi come al solito
V
nel pomeriggio di luglio la piazza vibra solo dell’acqua
lo zampillo festoso nella vasca e un coagulo di odori
tra il fritto e la vaniglia
discutiamo di lui così diverso che non ci assomiglia
tra lui (convinciti) è il presente e noi il passato
diventato niente
VI
è luglio in una nuvola bionda traccio segmenti
segnalazioni significazioni tu da lontano mi vedi
cambi strada sai che solo questo esercizio mi rimane.
Non abbiamo più tempo per parlarci
io ho i miei impegni di lavoro sempre più pressanti
mai un’evasione, mai un momento di abbandono
nella nostra casa e nell’orto gonfio di ortiche
tu del resto da quel 4 di agosto
non ti sei fatto più vivo
dopo la curva appena dopo quella che tu vedevi
come un palco affacciato sul paese
mi giunge il brivido del viale senza ghiaia
l’ultimo che hai percorso e ogni volta mi manca
come un ritmo o un fiato e un coccio di questa
mia vita abbandonato.
Veri e propri epitaffi sono i versi di Vincenzo Rossi circoscritti in un rapporto dialettico e memoriale sul significato della vita e della morte, all’interno di una atmosfera che ci ricorda Spoon River coi suoi momenti di affettuosa rivisitazione del tempo passato e di “confessioni” al limite della saggezza e della pietà umana.
EPITAFFI
Arresta i tuoi passi e guarda
come la possente gioventù
alzava la mia densa chioma
come questo vasto petto
era diga contro la tristezza
V
Perché mi sgolai
con la bava al labbro
mostrando denti di mastino
e veloci occhi di brace
senza degnare di uno sguardo
questa gelida tomba
cuore pellegrino non passare
IX
Grato ti sono
se nel pallido sole di novembre
ti ha guidato il suono di lenta campana
fin dove io tuo fratello
che brillò in sguardi di fuoco
e feroce avidità sulle cose
sono consumato dal silenzio.
X
O vivo che passi
davanti a questa pietra
guarda le secche braccia
della mia croce
molto io non ti chiedo
uno sguardo
un attimo soltanto
del tuo tempo vivo
CARLO FELICE COLUCCI
Chi approfondisce il discorso sul tema dell’esistenza è certamente Carlo Felice Colucci che, dalla propria esperienza di medico-scrittore, trae le occasioni migliori per radiografare la realtà mettendone in evidenza i segni del male con una anamnesi del Caso e della Storia .attraverso una indagine spietata sul corpus dell’esistenza dove la visione della morte è mascherata o mitigata da soluzioni consolatorie e ingannevoli adottate come “placebo”.
Tutto questo Colucci lo drammatizza con intelligente ironia, in mezzo al “respiro aspro dei morti”, tra ascultazioni di “sistoli e diastoli” e cuori d’infartuati e anginosi, tra mille domande senza risposte: “ chi siamo, dove, perché / aprire gli occhi e chiuderli per sempre / dai nobili ai manovali ai bari / mai fu trovato il corpo, attento, / ma tutti eguali e segnati / la catena degli ossicini i denti / sense nonsense Nord Sud, / solo un ‘incredibile dose / di ricordi nelle pause buie / un filo di fede in extremis / dopo aver chiesto l’ora esatta /. O in odore di santità/ il Signore ha chiamato/ e suiblimando si crepa/ alleluia/.
Da qui lo sforzo nel cercare il movente oscuro dell’esistenza attraverso la lettura dei segni della vita le cui pagine sanno più di epitaffi generali che di speranza..
Questo ”check-up” poetico e scientifico trova nelle “bianche leucosi” una delle cause naturali della fine del “corpo” visto in tutta la sua imperfezione e fragilità , anche se il poeta stesso sa di non poter “rispondere a tutto”, accentuando in “Notturno Cittadino” quella sua dichiarata e allarmante resa di fronte all’assenza di “altri curabili indizi” e andare oltre il lapidario “siamo non siamo” di “Memoria e fuga” , in attesa del “ritorno degli ostaggi”, come disperato e inutile tentativo di riappropriarsi delle illusioni bruciate dalla vita nei” campi di sterminio”.
Le anamnesi sulla realtà diventano alla fine, veri e propri consuntivi di vita che si sfiammano davanti alle pasque di ceneri ravvivate di soffusa luce , con i “ lumini avanti ai cari estinti” , a imperitura memoria del proprio — pater- o — mite patriarca-
EPILOGO
E com’era buia
la tua demenza
pater
com’era lunga impenetrabile
da un buco di memoria
il mondo in un girello
pigra storia e ferma
a un lampione di sapienza
centenaria,
bella di notte
così finiva
la riffa dei longevi
irriducibili
così barando e l’agonia,
ma che potevamo darti
noi vuoti dentro ormai
a guardia d’un sepolcro
che poteva dire
il sangue marcio delle quarantene?
Bandiera gialla ai vaporetti
all’innocenza amuleto vago
d’una età sepolta
e per fiore la rosa dei venti,
le saghe le saghe, invocavano,
variamente crudeli
dalla strada,
musica in piazza
banditore d’ex.
SINFONIA IN BIANCO E CROCE ROSSA
Dal fondo d’un lettuccio d’ospedale
di qua dal bianco intatto
non venni a chiamar giusti,
a luoghi un po’ stranieri guardiamo
dall’unica finestra
a un verde di pinete la vita
ma non si tocca non s’annusa non si può
se giaci ed alla terra aggrappato
per effimera vena per flebo per os
per la pelle per colpa e nessuno,
è presto per sapere dice il dottore
e nulla da toccare oltre il corpo oltre
nessuna breve nuova per crisi per lisi
nessuno che ci sveli se e al dolore
midriatiche pupille se
fissare in viso il male il tuo il mio
un male più di passo che altro
oppure, orrore,
stanziale e un po’ crudele bianchiccio
ribelle ai domatori ai
dottori al grande caso
col forcipe col bisturi l’ago
nessuno poi che turbi dal fondale
i candidi laccati villaggi
e molto bianco intorno con croce
le rosse croci in vena in flebo
scialbate le pareti se duole
con l’ago il silenzio per os
in maschera in guanti la scienza
l’avara mia scienza tesoro
di là dal gran ponte
guerrieri in attesa le febbri ignote
ragazzo che andava per comete
più feste nel cielo al peccatore
che a quei novantanove giusti
così mondo straccione ti guardiamo
da bianche voglie sulle gote di guarire
di qua dalle pinete ospitaliere,
così nascemmo in pochi
orditi cromosomi
coi geni i loci il male i miti
dall’uno all’altro pub a marciapiedi
salotti bari o cresi
e chi già crede siano immuni i santi
guariti e vaccinati trapiantati tra
s’attende quel dottore e
nessuno può svelare prognosi amate
né il tempo immemorabile che manca
nessuno né fedeli al giuramento
la nemesi al bivio Asclepio
con vita la vita con male incurato
affiora l’Atlantide e attende
effimero agisce il rimedio
e taglia e ricuce il cerusico nostro
l’esangue rodeo dei sopravvissuti
profondi giacigli di occaso
qualcuno che chieda la buona morte
per sempre nell’utero mater per amnio
per flebo per vena per sempre
gli infetti no, vanno per legge isolati
per germi con maschera e guanti
monatti ed untori si nasce si muore
un caso assai raro da notti bianche
io qui vi presento e le fobie
il nome diventa numero al letto
salute uno stato precario
dal quale mai nulla di buono mi attendo
curabili casi i sentimenti
sui nostri lettucci laccati
con diagnosi prognosi e cura
la scialba memoria una cisti
accadde che mentre in Gerico entrava
in strada vi fosse un cieco a mendicare
ragazzo che a un niente arrossivi
le date più assurde della tua storia
in pillole e fiale
nessuno sa l’ora il te mpo che manca
aspettano al ponte guerrieri,
liocorni liocorni anch’essi infermi
frammenti di sogno ben custoditi
così inerme e bianca la corsia
annotta in silenzio e croce rossa.
INVECCHIANDO
Col rimpianto amaro degli orti
il pendolo tradito
a Natale papà viveva ancora
attento alla sua digitale in gocce,
caute scommesse di futuro a bocce
noi per fede s’intende, per esempio,
la pelle iridata del mondo
restarvi spettatori a lungo
di amati enigmi paradossi il no
e di tanto in tanto un capogiro
un incidente dentro le mura,
nato a residente a
le piccole attenzioni dovute
ma in resto ci danno caramelle
i misteri della materia
e il telefono sempre guasto
meglio proteine che grassi e non fumo,
la maturità è tutto e crepò
saggiamente votato all’entropia
con soli tre denti e mezzo lato,
così rompo occhiali da presbite
e ci offrono medaglie,
in guerra sono i padri invece
a seppellire i figli e sia,
persone o vecchi personaggi a scelta
e chi a memoria recita giornali
violenza da sovraffollamento
neonato con organi al contrario
chi si converte in zucchero filato,
cercasi un’antica follia:
il giardino dovrà esser venduto
il caro estinto riconosciuto
ma davvero tornare presto
nel gran letto a giocare
e chiuso per ferie il Karma
l’ora esatta
o il codice cavalleresco
di quando ammazzo l’animale
e invecchio,
in attesa del giudizio universale.
IL MIO PAESE
Quando finisce qualcuno
portano da mangiare i vicini,
pesce secco e farina,
e il vento pigro di zagare
sembra dondolare solo
quella campana di Matteo.
I ragazzi, li mandano nudi
sulla spiaggia, a prendere meduse.
E duecento metri ancora
mentre tolgono santi e luminarie.
Quante medicine per guarire,
al mio paese anche la morte
viene scalza sotto il sole
e monda fichi d’india per le vie.
CIRCOSTANZA
Bisogna accompagnarli
questi votati a sparire
fino al momento estremo
aiutarli a passare in borghese
di là dal ponte fra due Nulla
e senza parere
senza mai complici ammiccare
come dire gli astri e la sorte
cader di cose quaggiù
di amare gocce per il cuore
nel bicchiere,
dita a intrecciarsi per niente
affusolare un tremulo segnarsi
in tanta buia luce al crocevia
tanto passar d’orbe comete
un andare e venire folle
e tutto all’infinito
eri tu il mio sosia tu
quel tornare imberbe
dove fischiava il merlo
qualche sorriso incerto e
semmai finale di partita a due,
pater,
ma a che misteri
nel morire tuo lieve
mi iniziavi
un pensiero alto aquilone brado
sui prati del Re,
sfiammano le secche parole
sempre più marginali scritture
ed io non so dove fermarmi
viaggiatore ignaro
a mutar lingua
e circostanza
AMATE GRONDAIE
“Le masse”, dicevano, le orbe folle
delle piazze, ogni pietra una festa,
all’ombra del Caso o della Storia
sciogliere enigmi proletari
e mai un senso, nemmeno d’adozione,
mai una vita fuori posto
manca un secolo esatto al grande corteo
avviso ai naviganti ai santi e poi
a quel tale sconosciuto calvo e tondo
morto d’infarto per la strada
riflusso nel privato finalmente,
noi siamo la patria siamo Dio noi
con quei radi falò sparsi nel vento
e sempre un confine da rispettare
la porta e il gas da chiudere bene
sempre dei bastimenti in partenza,
c’erano lampioni in ferro battuto
sul molo dove ci fingemmo
donne sole di pescatori
la scarna mano d’addio alle parole,
col lessico fatto a pezzi
la sfasciata sintassi dei padri
come avremmo potuto saputo
mimare l’antica pena del mondo
sfogliare la nuda margherita ormai?
Dire non dire e niente personaggi
tanto senso di colpa ci attanaglia
il gelo dell’umile armatura
nessuna trama da spacciare
né droga né sorte né altro né né
il gufo appollaiato sull’infanzia,
“spiacente, l’Atlantide non c’è”,
qui solo pochi ora possono udire
in silenzio il tamburo della pioggia
sulle amate grondaie,
preghiamo,
per il ritorno degli ostaggi
IN VIAGGIO
Uno con due valigie grandissime
e mai sapremo chi, e cosa portasse
e il soldato che arriva trafelato
assieme a cifrati ordini matti
io sto solo, invece, e non ho donne
o le serene monachine estive
dal gelato innocente sotto i voti,
chissà come sarà dopo tanto,
né somiglio all’uomo dei lustrini
ma dentro, un vecchio lessico infedele
un bastardo buono da odiare
con cura e nostalgia ragazzi
nati vissuti nel terrore,
chissà uno come farà dopo tanto
un diario di sistoli e diastoli
se manca perfino la memoria,
non è dove si nasce la terra
partenze departs qui e là
quasi” rosa la rosa ” fra i banchi
tutti fuori corso e scende l’ernia
scende la notte senpre con ansiolin
i lumini avanti ai cari estinti,
secoli che non abbiamo più verbi
da coniugarci la vita
la vita eterna amen,
farsi le provviste e sparire
con morale d’occasione
o la Storia nuda e cruda ecco
nel segno dell’acquario è il tuo,
impietriti inorganici “ passengers
are kindly requested “io sono tu sei
e lui uno che annunzia ritardi,
all’imbarco numero due eccetera
se con la fine o col principio
se in fila indiana per sempre
non più d’una razza per volta
se con parole o col silenzio
mite stagione di amnesie
oppure per zigote s’intende ed io
e un secco timbro sul passaporto
cambiando alla prima casamatta,
chi da grande, fortunato e tutto,
impari a contare le belle
statuine del ritorno
le remote bolle di sapone.
NOTTURNO CITTADINO
Coi giornali freschi di stampa
e tu le gambe lunghe della sera
la popart sui marciapiedi e uno guarda
uno, due se non hanno altro da fare
mormorando strane frasi di niente
come il cinese sfiora l’Occidente
passando in lontani torpedoni,
le facce chiuse in cieli finti
salgono, salgono dal profondo Sud
se non ti va di emigrare sta’ qui
dove non vagano più tra né voglie
sui corpi delle ragazze incinte
una banale emicrania a passeggio,
uno pelato sembra mi somigli
ma non io, non avevamo sosia
io son quell’altro fermo ai quadrivi
miliardi e miliardi di cellule, sai,
facendo amicizia con la notte in giù
fino a vuotarne bene il contenuto
a contarne le insegne sgargianti
e impacchettano statue e monumenti
comprese le mura di cinta e di noia,
alle calcagna d’ansimanti sogni
ancora la ronda dei soldati in tre
o quei brevi marinai allegramente
le navi scritte in oro sulla fronte
né vi sono altri curabili indizi
girotondi magri di drogati e di
bigi topi corrono ebbri, corri
il sangue sprizza dal pronto soccorso
e docile imbocca i tombini, laggiù,
prima ch’io ne riconosca il gruppo
la notte impudica già si denuda,
in ghingheri, fontane del tempo,
con la violenza ci fanno bottoni
quest’ultimo è sdentato e grida forte
mentre io giungo trafelato al portone,
le stesse ombre di ferro e di silenzio
qualche folle tornato dalla guerra
e più o meno il respiro aspro dei morti
GIOSE RIMANELLI
Ad una ampia campionatura di immagini-sensazioni e resoconti autobiografici, dove la sopravvivenza psicoemotiva di profondi soliloqui si alterna con i luoghi della memoria domestica e storica, tra visi, gesti, luoghi geografici diversi, come diverse ma non disgiunte da tutto il corpus poetico sono le due figure rappresentate dalla vita e dalla morte, che tra l’altro appaiono dominanti nella raccolta dal titolo: “Sonetti per Joseph” Caramanica Editore, 1998, s’affida Giose Rimanelli, tutto portato sul versante di un umanesimo illimitato e assoluto nella esaltante dichiarazione di un perduto bene che permane anche quando le rapine della morte mettono a soqquadro cuore e ragione e fanno della generosa illusione dell’esistere un delirio-rovello esplicato attraverso un lessico lirico assai singolare nella operazione di collegamento dei sentimenti , sia se si tratti di discorso neutrale che partecipe dei fatti e degli eventi. “Sonetti per Joseph” lancia messaggi psicoemotivi e linguistici che vanno al cuore della dialettica esistenziale, in una atmosfera familiare fatta di cronache e di racconti, di confessioni e delusioni , che si riannodano in un unico bozzolo dal quale fuoriescono filamenti memoriali, come disperato bisogno di ricucitura del tessuto quotidiano attraverso un’ampia galleria di personaggi, come la figura della madre, del Reverendo Mich ed i suoi cantori, di doppi se stesso del poeta, che riaffiorano come isole nel grande mare delle dispersioni con una febbrile volontà di esistere, anche dentro il “male di vivere”, non importa se poi tutto questo si riduce a uno smarrimento dell’io e a uno stupore delle cose passate e presenti.
RITORNO
LIII
Mia madre muore a Windsor, nell’Ontario,
in una casa abbandonata all’ombra.
L’abbraccio, la vezzeggio, non s’adombra:
lei sa d’esser sola nel suo santuario.
Qui a suo modo ognuno fa il solitario,
come a intrattenersi con la penombra
che a poco a poco invade i vetri, e sgombra
d’ogni residuo d’olio il lucernario.
Nella mia terra abbarbicata ai muri,
mia madre visse un riluttante esilio.
Ora qui siamo, nella sua: duri
da rompere col rimpianto, l’ausilio
dell’incognita, la testa agli scuri….
La Gloria? Passa sotto il peristilio.
Windsor, Ontario
Domenica 5 novembre 1995
MIA MADRE
XLVI
Joseph, non è morta , anche se lo penso.
Ha perso quasi tutte le sue piume
e il gesto, la parola. Già l’incenso
tinge la sua stanza di là del fiume.
Alla sua vita non c’è alcun compenso,
eccetto un pensiero: ci è stata lume,
porta aperta sul mondo in quel suo denso
ipotecare la speranza. Schiume
d’ignoto pianto battono le sponde
d’America, fino alla patria Italia,
e sfumano. Nessuno mai risponde.
Vanno e vengono, aggobbiti d’alia,
figli e nipoti e parlan di Laonde
la mamma/nonna, stelo della dalia.
Pompano Beach, Florida Martedì, 31 ottobre 1995
SALVE REGINA
XLIX
Aspetto la mia morte con lo sguardo
di mio padre, a cui sempre più somiglio:
chiaro, con tutta una sua grazia; il cardo
che pungeva è perso, tra grano e miglio.
Aspetto la mia morte, col ritardo
mitico dei treni, nel ripostiglio
della mia gloria; odorerà di nardo
e farro, vuota quanto uno sbadiglio.
La morte è rito solo per chi resta:
per me c’è il canto del Salve Regina
nella Valletta dove ognuno appresta
una tela sospirosa , in sordina;
e dove incontrerò te pure, in testa,
Joseph, a una brigata d’albaspina.
Pompano Beach, Florida
Giovedì, 2 novembre 1995
LA ROSA
XXXIII
Per i tuoi settanta, sapienza e amore
te ne danno appieno….venti di meno;
e, Dio voglia, ce ne saranno almeno
cent’anni ancora a salutare altre ore
di lieto conversare, di sereno
scrivere nel reciproco pallore;
è questa la vita, è questo il suo odore?
La barca cerca altra sponda, il seno
sempiterno che ci ripaghi a fondo
d’ogni umano dolore — quella spola,
Joseph, che tesse o inceppa il girotondo.
La rosa odora una giornata sola,
(come la nostra vita in questo mondo,)
e Amore canta, ride e se ne vola.
Election Day Pompano Beach, Florida Martedì, 6 novembre 1994
SIS
XVII
Mangiavano peperoni salati
sotto il fusto d’una palma, in un fosso
di fango e rettili, semi affogati
nei loro tatuaggi; e nient’altro addosso.
Uno d’essi si rosicchiava un osso,
ed un altro i capelli insanguinati
d’un terzo che piangeva, “Ummm, yes, ti posso…”
e mormorava un blues di stralunati.
“Yes mama, mama look at Sis, lei è fuori
on the levee, facendo il doppio salto
col Reverendo Mich ed i suoi cantori”.
“Rum in here, you little sow, lo smalto
sulle unghie is bad, girl, you know how? Se muori,
you little sow, mama too vola in alto.
Jacksonville, Florida
Sabato mattina, 17 settembre 1994
PREGHIERA
XXIII
La pioggia che ti sfruscia nel pineto,
e quella che t’affoga nei diluvi
è la stessa che monda e ti disseta,
è la stessa pioggia che carezza e urla.
Sei come il passerotto che si burla
sul filo del giorno giunto a compieta,
e si stordisce al buio negli effluvi
di paludi che vegliano il canneto.
Joseph, aiuto! Sempre stessa storia
on Television, da mattina a sera:
soap opera, politica, violenza.
Questa porosa cosa, la mia scoria,
(permetti?) eleva ancora una preghiera:
che presto arrivi l’ultima partenza.
Jacksonville, Florida
Martedì, 11 ottobre 1994
VENTURA
XXV
Ognuno costruisce la sua casa
nel deserto, ed ara, scava e coltiva.
Poi — passa un giorno passa un anno — arriva
il vento e l’acqua o il fuoco e la travasa.
C’era sempre un fiore sulla cimasa
che ci donò guidogozzano: estiva,
con i colori di Domani, e viva…
come i bei sogni morti in quella casa.
Ora la gente passa e mi domanda:
“Di cosa ti lamenti, la paura?”
Tutta la vita è fatta di chi sbanda,
o arranca, cercando la via sicura.
Ma poi si affonda. Paura? La banda
suona al solito il blues e la ventura.
Jacksonville, Florida
Sabato, 15 ottobre 1994
CATULLIANA V
XLVIII
Godiamo in santa pace il nostro amore
perché la vita è luce che si spegne.
Lo dico a Bimba con aperto ardore
siccome a lei non vanno le consegne,
le morali delle favole, le ore
attorte e un tantino pregne alle insegne
delle scuole, o assorte nel luccicore,
Joseph, di tutte quelle cose degne.
Ho perso sempre tutto nella vita,
Joseph rispose , eccetto la mia croce.
Vi sono entrato come in una gita,
petto in fuori, melodica la voce.
Onestamente, me la son goduta:
godendo anche l’amaro della noce. (66)
Pompano Beach, Florida
Mercoledì, 1 novembre 1995
NICOLA IACOBACCI
Il risultato sorprendentemente più avanzato sul territorio delle immagini-percezioni, (quando l’occasione poetica non è dettata solamente dalla suggestione del paesaggio o dalle relazioni storico-familiari o affettivo-sentimentali), è quello della prefigurazione o rappresentazione del Nulla, come ci viene proposto da Nicola Iacobacci il quale affidandosi a un lessico scopertamente fruibile anche nei termini analogici, riesce a far proprio un messaggio poetico in sintonia con i brividi culturali del nostro Tempo, che sono poi quelli della percezione del trionfo dell’empirico e della crisi del trascendentale.
In quest’ambito il senso profondo del sentimento della morte, recepito come fatto ineludibile, assume nella valenza della denuncia un significato di forte impatto sociologico.
Da qui il recupero tradizionale del “consolo” o della partecipazione al dolore , che poi altro non è che un ulteriore richiamo antropologico all’antico culto dei morti magnificamente descritto ne: “Il cerchio si stringe”, un testo singolare, interamente trasferito sul piano delle impressioni e dei sentimenti: “Attorno al morto vegliano gli amici; / per ingannare il sonno bevono vino di melappia; / tra un sorso e l’altro la consolazione / d’essere vivi:/. Ma dove l’immagine del “viaggio” s’affaccia con più graffiante incisività, portandosi a un livello di prefigurazione del rito funebre , in particolare quello della vestizione, con tradizionali richiami a figure mitologiche è nell’ultimo testo che chiude il volume “La baia delle tortore”, sintesi di una sincera e appassionata rigerminazione dell’amore che va oltre i confini stessi segnati dalla scia della barca di Caronte :”Agghindami a festa. / Il vestito di seta, la camicia, celeste, / come i miei occhi pieni di luce. Sei tu la luce e i miei occhi che vedono oltre la barca / e il fiume di Caronte, l’angolo di cielo / dove aspetterò il cavallo alato che ti condurrà da me./
In quest’ultimo senso la poesia di Nicola Iacobacci toglie all’impietosa presenza del Nulla il suo potere di distruzione e di terrore “accettando anche, serenamente, la morte, come un momento necessario di quel fluire perenne” (Carlo Saggio)
CIV
L’ultimo rintocco spezzerà il volo della rondine
nel gelido cristallo d’alba equinoziale.
Non coprirmi di lacrime e di baci.
Gioia è l’amore, cuscino d’erba e viole,
non pietra nel calco d’un sosia glaciale.
Bianca la veste, fiori d’arancio, fulgida spada
sul velo che copriva il tuo rossore. E ti baciai.
Il miele grondava dai telai dell’arnia
quando la maschera e il fumo allontanano la pioggia
e le api sui poggi di campanule e ginestre
gonfie di polline e profumi.
La vita sembrava eterna. Ed è eterna
nel sorriso delle figlie che nuotano nel grembo
come in un lago d’acqua azzurra e quieta.
Restami accanto, conosci il mio tremore
e la paura di restare solo.
Il mondo schiaccia ogni saggezza, non il pensiero,
fragile specchio che ha la forza di respingere il sole.
Agghindami a festa.
Il vestito di seta, la camicia, celeste,
come i miei occhi pieni di luce.
Sei tu la luce e i miei occhi che vedono oltre la barca
e il fiume di Caronte, l’angolo di cielo
dove aspetterò il cavallo alato che ti condurrà da me.
Non scordare le mie scarpe di vernice, silenziose e comode
Le tue scarpe di raso .
Insieme, sulla scala di vetro dell’eternità.
IL CERCHIO SI STRINGE
Perché dovrei pensare come gli altri
e credere alle cose che durano nel tempo:
è la vita che non dura.
Attorno al morto vegliano gli amici;
per ingannare il sonno bevono vino di melappia;
tra un sorso e l’altro la consolazione
d’essere vivi. Ma il cerchio si stringe,
il filo spinato s’attorciglia intorno al cuore
duro come il cristallo del lago ghiacciato
che cede improvviso al sole che rinnova
la gioia di vivere.
GLI ORECCHINI DI CORALLO
Gli orecchini di corallo
m’incantano più della fonte di maga
nel giardino degli uccelli;
come due bacche rosse
tintinnano sfiorati dalle labbra,
parole dal suono di foglie secche
tritate nella mano e ventilate
senza che resti nulla di ciò che dico
perché non dico nulla di ciò che penso.
Un giorno forse sarò sepolto nella neve;
dalle mie parti fiocca a pelo di gatto
e la campagna diventa un manto
senza strade né foglie;
travi tarlate crollano sotto il bianco peso.
A te non piace il mosto cotto
sulla neve che crocchia nel bicchiere
perché la neve è una lastra
sul tuo cuore di fanciulla
inorridito dal pensiero della morte.
QUANDO MUORE LA REGINA
Quando muore la regina degli zingari
quattro cavalli neri portano la bara
sul manto di garofani steso sull’asfalto.
Anche gli zingari hanno la corona
sul palo della tenda al centro del campo
tra mucchi d’erba
e pietre affumicate dal freddo e dalla fame.
La libertà è la maschera che copre la vergogna.
Libero è chi lavora forgiando con le mani
il metallo per ferrare i cavalli
e correre sulle prode erbose dei pascoli,
non chi ruba il fieno del vicino o la gallina
come cagna randagia per nutrire la nidiata
dalla buca aperta nella rete.
E i figli piangono venendo al mondo,
la pelle scura e il sangue caldo
e la bocca aperta alla gonfia mammella.
IL SONNO E’ LA MORTE DEI VECCHI
L’ala del passero preso alla tagliola
è immobile sul muro rosso del bastione.
Odore di sorbe sui tetti
e di cotogne che il vento gonfia
sul dorso della costa
quando i tordi, a coppie,
scompaiono tra i rovi.
L’ombra sonnolenta si sdraia sotto il tiglio
e nelle viuzze dormono i ragni
accanto alla preda impigliata nella rete.
Il sonno è la morte dei vecchi
sui scanni di pietra addossati ai muri scalcinati
delle case rosse di gerani.
A MIA MADRE
In questa stanza bianca
la lingua è legata nella bocca
come il battaglio della campana
nei giorni di passione;
ancora un giro intorno all’asse:
l’eternità gorgoglia nell’acqua
accanto alla bombola d’ossigeno.
Dal vetro brunito della finestra
lampeggia la prima lucciola;
tante lucciole tra i fili della memoria
impigliati a tarda sera
nei cespugli fioriti della costa.
E’ il segno dell’età,
felice perché passata:
l’attimo non rivela la gioia
o il dolore che lo sostiene.
Tempo d’addio:
la sedia di paglia è già pietra
per l’allodola stanca di volare.
TORNEREMO INSIEME
Mio padre e mia madre
non hanno più voce
ma continuano a cantare
con le mani tra le spighe;
il tempo non tradisce mai
quelli che aspettano.
Torneremo insieme
nella luce che solleva gli oceani:
l’attesa della primavera
finalmente si coprirà di rondini.
Entreranno le rondini nella mia stanza
con un soffio d’aria nuova.
O è forse la pietà
che addolcisce il senso delle cose,
le ore di pioggia nei pagliai,
le notti pesanti come pietre,
il pensiero del domani.
MARIO M. GABRIELE
Con “Astuccio da Cherubino” il sondaggio esistenziale assume un ruolo prioritario che si dilata “lungo una esplorazione della morte piena di infinita pietà” .(Giorgio Bàrberi Squarotti). L’aspetto storico e domestico riservato alla figura del caro estinto, rievocato nel momento del distacco, permette un’avvolgente visione e rapporto tra l’Hic et nunc e l’oltre, spaziando nella parapsicologia “rinuncio all’assurdo, ai contatti / con le ombre, mentre gira a vuoto / il nastro del vecchio Grunding / per un tuo messaggio che non arriva /”, e nella metempsicosi “Io, in disparte, / lontano da quella archeologia / ti penso altrove: bruco, passero, girino./ ”fino a recuperare attraverso “il vetro che si incrina” l’improbabile segno proveniente dall’aldilà, come estremo tentativo di porre in una dislocazione atemporale l’immagine paterna passata ormai, definitivamente, nella penombra “se per te mi fingo / una nuova vita e mi calmo soltanto / sapendoti felice in altre ionosfere,/ fuori da questo luogo / che se mi volgo intorno / è una lunga città di morti, di segni, / di epitaffi strani./”
“Il vocabolario di Gabriele è estremamente semplice desunto com’è dalla quotidianità del vivere, ambiguamente usato per esprimere il “mondo dei morti”.
C’è da notare che la struttura del testo nel suo complesso si sviluppa, a partire dalle Epigrafi, in un discorsivo che ha come interlocutore il Tu. Chi non ricorda il “tu” di Montale? Chi non ha nella mente il dialogato di Eliot? Chi non ricorda lo Spoon River di Masters? Ma il “tu” di Gabriele è nello stesso tempo il poeta che si guarda allo specchio, è l’uomo dell’oltretomba che si evidenzia come anima, ossia come umanità.. (Gaetano Salveti: Introduzione alla poesia di Mario M. Gabriele su Nuova Letteratura 1985).
“Poesia sociale, dunque, che si veste di analogie e di simboli, che assume la solennità pensosa di una parabola evangelica o il tono sferzante di una indagine rivelatrice”. (Intervento critico di Lidia Ratti a “Il giro del Lazzaretto di Mario M. Gabriele su QG., anno XIV novembre-dicembre n. 149; dove “ l’esilio e l’eclissi scandiscono i ritmi di un esistere, segnato da morti e resurrezioni, da ciclici abbandoni e ritorni alla voluttà della parola, tra sogno e veglia. Il risultato allucinato, ma autentico è l’essere, al principio e alla fine, ombra di se stessi, immagine stemperata di una presenza, che evoca fantasmi di assenza”. (E’ quanto si rileva nella Introduzione di Francesco D’Episcopo nel volume Moviola d’inverno di Mario M. Gabriele, Riposte, 2003).
EPIGRAFE N.1
Bisognava attendere,
essere composti nel dolore
trovare un angolo e rimanere soli
mentre c’era chi trafficava per le stanze,
chi raccattava la speranza caduta a pezzi
e l’abisso oscuro allontanava da me
ogni tu forma, i molteplici colori……
Anche così
La morte non ha reciso molto
se qui, nella tua casa,
ancora c’è chi ti ravviva di porta in porta,
riesumando oggetti, incespicando storie
per nulla desuete o lacrimose,
se m’ostino come sempre
ad attendere nel vetro che s’incrina
il tuo graffio dall’al di là.
EPIGRAFE N. 2
A volte
è come un rito d’altri tempi:
c’è chi accende il lucernario,
chi divaga sulle notizie della lapide
e gennaio fa prodigi contro un muro
di gerani e non ha senso abbellirti
come un piccolo giardino
se per te mi fingo
una nuova vita e mi calmo soltanto
sapendoti felice in altre ionosfere,
fuori da questo luogo
che, se mi volgo intorno,
è una lunga città di morti, di segni,
di epitaffi strani.
EPIGRAFE N.3
Non sempre la tua assenza
è un lunghissimo-black-out-.
Spesso riemergi dal buio
in piccole intermittenze, baluginii,
vicino al lumino sopra la consòlle.
-Non è che si ricavi molto con le preghiere-
dico agli altri
mentre sgranano la corona e attendo un tuo segnale
-tremolio o luccichio-,
brevi notizie dal tuo mondo.
A quest’ora,
-essenza o crisalide-
probabilmente già in un’altra dimensione,
dovrebbe soccorrerti un Dio di pace e non di guerra.
*
La tua fede si riduceva al minimo:
pochi idoli, feticci effimeri
di chi crede che la vita sia solo un caso.
La Pasqua ti abilitava,
ti scioglieva dal martirio
del Dio assente o presente.
E come avrei allora potuto non amarti
scioglierti dal dubbio totale?
-Si tratterà- dicevo,
-di un vuoto da colmare-.
E ne venivi fuori, titubante,
un poco in disagio per il lungo subbuglio
della ragione al profilo morbido dell’aurora.
*
Il tuo guscio di noce,
troppo angusto in un viaggio d’eccezione,
era un astuccio da cherubino
e tu un archetto incantatore
per cipressi e rododendri,
sempre più in fondo a un cunicolo di sogni
se mai ne avessi uno.
Ma è assurdo
pensarti altrove, chiudere per sempre
con gli anemoni e le cose
lungo un fiume di nebbie e di carrubi,
con un lupo trifauce a guardia dei tuoi occhi,
lasciati al buio, al silenzio che deturpa.
*
Come posso ritrovarti
tra mattoni e calcina,
qui tutto ben squadrato, livellato,
con questa frana all’improvviso
di terra e di radici?
E’ già molto
ricomporti nel ricordo,
mentre c’è chi tenta l’omelia
sul tuo bozzolo di neve.
Se qualcosa emerge
è subito un collage di fossili e lumachine.
Io, in disparte,
lontano da quella archeologia,
ti penso altrove: bruco, passero, girino.
Parlarti è impossibile
se in fumo o in sogno
sempre mi ritorni
per un monologo o per le tue pozioni.
Ma fu il colpo d’ala quando ti chiesi
perché mai ti trovassi nella necropoli.
Ora l’inferno è sapere
quando riapparirai,
come farai a battere alla porta
con quelle mani già ali di farfalla?
*
Sempre verrà l’autunno,
il rosso delle vigne
a terrazze sulle colline
fin che dura l’estate
sui boschi e i ramarri.
E’ un’erba verde
la voce che non torna
chiusa nell’orto antico
nel tempo dell’amore.
Legno nero e fumo.
Si riapre il dolore
come una finestra vuota.
Sempre se ne va l’autunno
in una tristezza
che nessuno più direbbe antica,
di ramo in ramo, di foglia in foglia,
come un furto vero
il nostro pianto greve.